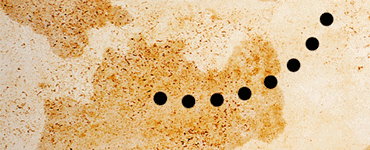Quando l’uomo smise di essere primitivo
No, non sono nè selvaggi, nè barbari, nè bestie. Gli uomini addomesticati chiamano se stessi «civili» e pronunciano questa parola con un carico di vibrazioni etiche e di autostima. Eppure… eppure alla lettera civile viene da civis, che in latino significa soltanto «colui che abita in città».
Abitato da persone civili da svariati millenni e ricoperto dalle loro città, il pianeta sembra prossimo al collasso. I più civili tra questi abitanti delle città si preoccupano di non creare allarme: certo, il clima si riscalda, ma è un episodio tra altri… la popolazione cresce, le zone desertiche si estendono, si allarga il buco dell’ozono, le specie scompaiono insieme alle foreste pluviali, la gente muore di fame su tre continenti e si gonfia di psicofarmaci nelle altre lande, più civili, dove si respira aria inquinata e ci si ammala di tumore. E tuttavia il problema, per questi signori, non sta nella civiltà. Anzi, dobbiamo essere ancor più civili: ci vuole il nucleare per rispondere ai blackout elettrici, tuona Bush, e più guerre per ridare fiducia ai consumatori.
Si può sostenere – e di solito si fa proprio così – che il problema non sia la civiltà nel suo complesso. Che i problemi che attanagliano l’umanità siano imputabili a circostanze economiche, da affrontare singolarmente. Ma questa prospettiva, che trova così tanti sostenitori tra assessori e ricercatori in carriera, che parla di «sviluppo sostenibile» e di «salvaguardia delle specie protette» non è quella di questo libro. C’è chi ritiene che l’umanità di oggi non sta solo preparando un incubo per i propri discendenti, ma sta replicando, su scala magnificata e accelerata, gli errori commessi in antico da romani, sumeri e cinesi: tagliare i boschi, dividere i terreni, stabilire confini di proprietà. Fissare misure e strumenti di calcolo. Sviluppare alfabeti con cui scrivere leggi. Alzare mura per fare prigioni dentro alle città, e poi intorno alla città un muro ancora, a fare anche di questa una laboriosa prigione. C’è chi ha poi guardato a quei pochi popoli di «selvaggi», che ancora vivono di
caccia e raccolta nelle regioni più inadatte alla civiltà del pianeta.
Uomini senza fede, nè leggi, nè re… erano quindi, secondo i missionari cattolici, poco più che bestie. Ma i boscimani e gli aborigeni, come adesso ammettono anche i viaggiatori e gli etnologi, quando possono vivere secondo le loro abitudini millenarie sono sani, si nutrono in maniera soddisfacente, non dedicano più di due, tre ore al giorno a problemi di sussistenza materiale. E soprattutto non distruggono se stessi e il loro ambiente. Il resto della giornata la passano a ridere, intorno al fuoco, a inanellare racconti che descrivono le loro origini o il loro territorio, con linguaggi singolarmente ricchi di parole e dettagliati, magari privi di numeri e di categorie temporali, perchè loro, loro sì, vivono nel presente e non hanno da contare i quattrini per arrivare in fondo al mese. Ecco allora che sull’onda di un inte-
resse diffuso, soprattutto negli anni ’70, di rivalutazione dello stile di vita delle società selvagge e di critica dell’involuzione tecnologica e autoritaria dell’occidente, un filone di pensiero è fiorito negli Stati Uniti. Là, nell’Oregon come sui monti Appalachi, la wilderness, la selvatichezza, resiste ancora ai colpi di martello dell’uomo civilizzato. Là, la preistoria è appena sotto i piedi: una delicata punta di selce, perfetta nel suo parallelismo, puoi incontrarla dopo un rovescio di pioggia sul greto di un torrente, a ricordare che si poteva vivere di poco, possedendo solo ciò che si poteva trasportare, muovendosi sempre, costruendo i propri semplici attrezzi con una tecnologia di legno e pietra che non necessitava di figure di specialisti.
A partire dagli anni ’80, mentre la crisi dei movimenti di protesta dei decenni precedenti porta ad un ripensamento sul ruolo dei marxismi e delle critiche politiche, si comincia a leggere meno Marx e Bakunin e si cammina di più per i boschi, portandosi dietro Walden di Thoreau, le memorie di Geronimo e una etnografia degli Inuit.
Gruppi di ecologisti radicali si moltiplicano: ci si raduna per impedire il taglio dei boschi, per sabotare la costruzione di una diga, per liberare i visoni dalle gabbie degli allevamenti. Una guida forestale, Edward Abbey, scrive un romanzo che è un’apologia dell’azione diretta in difesa del pianeta: The Monkey Wrench Gang. Il libro è un successo. Abbey si ripete con un più tecnico manuale di sabotaggio e inizia a partecipare alle attività della rivista e del gruppo di «ecologia profonda» EarthFirst! che proprio a Eugene (Oregon) – dove vive Zerzan – più tardi sposterà la propria redazione.
Nel 1983 viene dato alle stampe il saggio Against His-Story, Against Leviathan, del libertario americano Fredy Perlman, collaboratore della rivista anti-tecnologica Fifth Estate. L’autore vede la civiltà emergere dai sistemi di irrigazione dei sumeri, che per la gestione di questo sistema idraulico svilupparono una casta di specialisti, la cui autorità si estese sul corpo sociale. Da questo primo germe autoritario si sarebbe sviluppato il primo Leviatano, che stenderebbe la sua ombra, la storia, con un carico di guerra, schiavitù e infelicità.
È sempre Fifth Estate ad ospitare gli scritti di autori su posizioni attigue a quelle di Perlman. Zerzan è un collaboratore del gruppo, passa molte ore nella biblioteca di Eugene a leggere storia e antropologia. Inizia a porsi il problema delle origini dell’alienazione, si chiede anche se «facoltà» che nei libri e nel senso comune sono considerate come «date a priori» non siano invece umane, troppo umane: abiti culturali da smontare con una analisi genealogica. Inizia un’indagine sulle categorie alla base della nostra percezione e della nostra alienazione: il tempo, il numero, il linguaggio. Scrive anche dell’agricoltura, perchè nella nuova ottica, che viene chiamata primitivista, o più precisamente anarco-primitivista, si sottolinea la rivoluzione neolitica (l’emergere della produzione del cibo, vale a dire dell’agricoltura e della domesticazione animale) come spartiacque tra due ere. Da una parte quindi un’età dell’oro che si è estesa lungo tutto il paleocene, con una umanità dotata delle nostre stesse capacità cognitive e priva di autorità e lavoro, con una relativa assenza di malattie e uno stile di vita egalitario; dall’altra un mondo spaccato da guerre, dove il pane lo si guadagna con la maledizione del sudore, con medici che curano le ferite del corpo e preti che invano cercano di risarcire quelle dello spirito. E a proposito di corpo e spirito: un fiorire di dualismi, a seguire il distacco tra l’uomo e la natura. Inizia la civiltà, finisce la comunità.
Il libro di Zerzan dà molti spunti e può lasciare il lettore, soprattutto quello europeo, interdetto. In fondo noi europei siamo ultra-civilizzati. Guardiamo ai greci, e ci dimentichiamo che la loro società si reggeva sullo sfruttamento degli schiavi. Guardiamo agli etruschi e cantiamo le finezze delle loro pitture tombali (realizzate per il sonno eterno dei principi, con il sudore delle maestranze) e ci dimentichiamo del taglio delle foreste di leccio originarie che, nel nome della metallurgia, forgiatrice di spade, ha spogliato gli ecosistemi ancestrali dell’Etruria. Ma in Australia la preistoria è resistita fino a quasi due secoli fa: prima che sbarcasse Cook nel 1770, a portare la civiltà britannica (e pochi anni dopo farsi ammazzare dalla lancia di un selvaggio delle isole Sandwich), nel continente australe non si conoscevano i dubbi meriti del progresso, che faceva morire a Manchester gli umani forse anche prima dei loro coetanei aborigeni, e sicuramente li faceva vivere peggio.
Per questo vorrei invitare a leggere non solo Zerzan, ma anche qualche libro che descriva lo stile di vita dei raccoglitori-cacciatori odierni: i boscimani, ad esempio, ma anche gli Yanonami, più aggressivi. Si può iniziare un viaggio meraviglioso tra i costumi dei primitivi contemporanei, e vedere ad esempio come gli Yanonami trattano i capi. Gli Yanonami sono un esempio di società senza potere, e tuttavia hanno capi. Il capo è un mediatore, ma non può coercere nessuno. Dove non c’è coercizione, dove non c’è obbedienza, non c’è potere. Il capo può esprimersi, ma nessuno è tenuto a rispettare la sua opinione. Quando non c’è accordo tra i membri, le tribù si dividono, salvo poi riunirsi in seguito se un accordo riemerge. Nei confronti dei primi germi di autorità c’è una splendida diffidenza. Non è raro tra gli Yanonami che un capo che voglia affermare la propria autorità si ritrovi escluso dal gruppo.
Un esempio molto divertente, citato dall’antropologo francese Clastres, è quello relativo ai tentativi del governo brasiliano di avere un rappresentante degli Yanonami per trattative connesse a progetti di sfruttamento del territorio di questa popolazione indigena. I brasiliani vogliono un capo, un rappresentante, qualcuno che parli per tutti, un politico insomma. Ecco il comportamento degli Yanonami: o mandano lo scemo del villaggio, o mandano qualcuno a cui interessi fare il capo. Colui che si fa avanti per il ruolo di rappresentante, diventa lo scemo del villaggio, e si fa oggetto di scherzi, pesanti ilarità, forse anche fenomeni di bullismo. Con ironia e lo sberleffo, si tiene l’autorità nel fango.
Dopo l’etnologia, un altro filone di critica che ha affinità con il primitivismo è l’archeologia radicale: una corrente teorica interna all’archeologia accademica di lingua inglese, che utilizza la documentazione archeologica al fine di mettere in discussione lo stile di vita della civiltà occidentale. Secondo l’archeologa americana Theresa Kintz – autrice della prefazione dell’ultimo libro di Zerzan, Running on Emptiness (2002) – gli archeologi potrebbero essere dei critici molto persuasivi dell’insostenibilità dello sviluppo economico. È possibile sostenere che l’espansione della civiltà è pericolosa per l’umanità e le altre specie del pianeta. Dalla documentazione archeologica apprendiamo che lo sfruttamento eccessivo di risorse circostanti gli insediamenti umani, la crescente complessità della cultura materiale e della tecnologia, la stratificazione sociale, sono pericolosi per l’uomo e l’ambiente. In Italia l’archeologia accademica, sebbene studi lo sviluppo e il collasso dei sistemi sociali e delle civiltà, si guarda bene dallo sviluppare analisi di questo tipo nei suoi rapporti. Gli archeologi italiani si accontentano di fare i loro scavi, quando ne hanno la rara possibilità, compilando le schede ministeriali di scavo con superficiali resoconti che utilizzano un numero abbastanza limitato di termini tecnici, una sorta di lista della spazzatura, l’elenco dei manufatti raccolti e la loro collocazione topografica, senza tentare di rivolgersi al quadro generale che
ospita questi manufatti e racconta l’estinzione degli individui che li possedevano. Al contrario, negli Stati Uniti un approccio meno idealista e meno ingessato, volto ad indagare le tecniche elementari di sussistenza (che aspetto aveva quel sito? di cosa era fatto? chi lo utilizzava? dove gettavano i rifiuti? chi e come produceva gli strumenti di pietra? da dove veniva il materiale usato? dove si faceva la ceramica? dove tenevano gli animali domestici se li avevano? dove macellavano gli animali? che piante mangiavano? seppellivano i morti? dove e in che modo?) ha permesso di elaborare contributi anche tecnici che sono poi confluiti nell’opera di Perlman e di Zerzan.
Per tornare appunto all’opera di Zerzan, un altro elemento di rilievo è il ruolo devastante del simbolismo, come attività di sostituzione e delega che si realizza nei linguaggi. A questo proposito uno degli autori più citati da Zerzan, anch’egli critico – benchè più moderato – del progresso e della tecnologia, è Lewis Mumford. Mumford sostiene in Arte e tecnica che la storia dell’umanità è segnata da questi due elementi, il simbolo e lo strumento, e che il predominio dell’uno sull’altro costituisce modelli diversi di società. Le società simboliche sono basate sui libri, sui rituali, sulle seduzioni simboliche del costume, della pittura, del pubblico cerimoniale; le società tecniche invece si basano sulla tecnica, sull’oggetto, sullo strumento. In realtà ogni periodo vede una presenza dell’uno e dell’altro elemento: simbolo e strumento si integrano e rinforzano allo stesso tempo. Il progresso scientifico, che appartiene alle culture dello strumento, non è esso stesso un simbolo, un mito? E la scienza non ha poi i suoi cerimoniali, i suoi riti di iniziazione accademica, le sue parate pubbliche? La moltiplicazione dei simboli che mediano la vita degli individui dà luogo alla loro svalutazione. Così ci ritroviamo a vivere in un mondo di seconda mano, di fantasmi, di riflessi, in cui i simboli costituiscono l’unico campo della nostra esperienza. I simboli si accavallano, le metafore linguistiche sono sempre più usurate, mentre parlare diventa un brusio di fondo in esistenze noiose: il risultato è l’isteria e la dissociazione dei parlanti.
In uno scenario così avvilente non sappiamo più relazionarci gli uni con gli altri. E che dire del nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda? Arrampicarsi, pisciare nel bosco, nuotare in un fiume… molte persone, dopo una vita spesa in contesti urbani, spesso non riescono a fare neppure queste semplici esperienze. Peggio ancora, oltre le parole non sappiamo andare: non siamo più capaci di esperire la natura oltre il linguaggio; non riconosciamo gli animali dal loro richiamo, non sappiamo più leggere le orme del loro passaggio, scrutare le nuvole, riconoscere i venti, curarsi con le erbe selvatiche, distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi. Non sappiamo più accendere il fuoco con due legni e le foglie secche. Non sappiamo più trovarci da soli il cibo di cui abbiamo bisogno, o costruire gli attrezzi che ci necessitano. Siamo dipendenti dalla mega-macchina del potere, che ci tiene come bestie mansuete: alla catena dei bisogni indotti. Ecco, per molti è arrivato il momento di smontare questa macchina, prima che essa ci distrugga completamente. Le società primitive per migliaia e migliaia di anni hanno rifiutato di svilupparsi, di crescere nel numero e nella tecnica, anche se ne avevano tutta la possibilità. Sapevano che non si può distruggere tutte le risorse, che è necessario muoversi sempre da un posto ad un altro ed evitavano di espandersi all’infinito: vivevano in bande di poche dozzine di individui, per non distruggere l’equilibrio di una zona.
Non sappiamo se la società del futuro assomiglierà ad una società primitiva o una discarica di lamiere inerti. Quel che è certo, e questo è un indubbio merito di Zerzan e degli altri primitivisti, è che adesso non si può più sostenere che la civiltà ci ha salvati da un passato brutale e orribile. La descrizione di Hobbes è una menzogna del potere. La guerra di tutti contro tutti inizia con la proprietà dei terreni a scopo agricolo, vale a dire con la civiltà, con la rottura neolitica dello stile di vita della caccia e della raccolta. Se la civiltà non è un passo inevitabile nella storia della specie umana, se il 99 per cento del cammino della vita umana sul pianeta è stato fuori dai sentieri della civiltà, allora non ci sono più scuse per accettare di vivere in un mondo che assomiglia ad un vascello lanciato in una corsa disperata contro le rapide. È arrivato il momento di cambiare direzione. È arrivato il momento di ammutinarsi.
(Per gentile concessione di Stampa Alternativa, dall’introduzione a Primitivo attuale di John Zerzan).
–