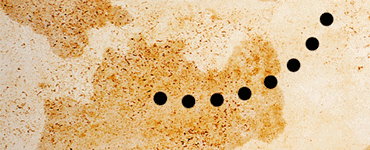Al di là delle retoriche diffuse sull’essere pro o contro l’ospitalità per gli stranieri, i profughi o i migranti, il tema dell’ospitalità ci pone interrogativi in maniera molto più radicale. La riflessione del professor Paolo Mottana, docente di Filosofia dell’educazione.
Ciò che è in gioco, parlando di ospitalità, è la capacità di accogliere ciò che possiamo chiamare “differenza”. E le differenze a cui siamo intolleranti aumentano di giorno in giorno.
È come se il virus dell’intolleranza ci venisse inoculato giorno dopo giorno, e non necessariamente nei confronti di ciò che ci è davvero lontano ma spesso anche per ciò che abbiamo molto vicino, per ciò che ci riguarda intimamente, per ciò che ci abita interiormente.
Una civiltà sempre più illuminata, detersa dall’ombra, igienizzata, individualista, diventa inospitale per tutto ciò che evoca l’oscurità, per ciò che contamina, per ciò che muore, per ciò che evoca il dolore, per ciò che minaccia le nostre celle autistiche sempre più disinfettate e protette.
L’inospitalità che le nostre città hanno via via lasciato espandere, accettando di divenire unicamente spettacolo delle merci, intreccio di strade in cemento che assicura al movimento incessante e veloce dei motori il primato, ha fatto scomparire da esse la presenza dei bambini e degli adolescenti, confinati in edifici chiusi o in percorsi vigilati e ortogonali. Gli animali sono costretti in spazi cintati e così tutti coloro che non si muovono in linea retta e velocemente, seguendo i tracciati prescritti.
L’immagine delle nostre città assomiglia molto a quella delle nostre nicchie autistiche, a quelle di noi stessi, sempre più centrati sulla cura della nostra autoaffermazione, della nostra carriera; non è però ben chiaro quale sia davvero la posta, probabilmente il successo che, come tutto ci racconta, è solo la perdita definitiva di sé, del proprio volto e della propria personalità, non certo la sua esaltazione.
Nell’incedere sempre più veloce verso le proprie mete di successo, tutto ciò che non procede alla stessa andatura deve essere abbandonato, siano essi figli, compagni, amici, idee. Tutto viene triturato ed espulso da questi atomi lanciati verso un’ascensione senza perdono, senza compassione, senza delicatezza.
Diventiamo tutti meno ospitali verso le nostre stesse debolezze, i nostri malanni, le nostre insufficienze, i nostri dolori, che devono essere al più presto soffocati, guariti, espulsi.
L’anestesia per il dolore intorno e dentro, per lo sporco intorno e dentro, per l’oscurità intorno e dentro, è sempre più diffusa. Ed è a partire da questa anestesia e insofferenza che il cerchio dell’intolleranza e dell’inospitalità si amplia e si diffonde.
Quando visitare il genitore malato o accudire il figlio con la febbre o semplicemente dedicare del tempo al proprio tempo, al proprio silenzio, alla propria imperfezione, vulnerabilità e debolezza diventa uno spreco, una perdita, un venir meno al proprio programma di successo, allora sì che possiamo parlare di inospitalità.
L’ospitalità inizia da noi, dal rispetto per la nostra fragilità, per i nostri lati oscuri, per il nostro sporco e per le nostre parti mancanti o straniere. Fintanto che non avremo assolto al dovere umano fondamentale di offrire loro rappresentanza, accudimento, tenerezza, la sofferenza fuori, lo sporco fuori, la barbarie fuori, lo straniero fuori saranno solo un pretesto e un effetto della nostra profonda trascuratezza per la pienezza della vita, che, quando c’è, si accompagna sempre alla solidarietà per tutto ciò che è debole e inatteso, dentro e fuori di noi.
__________________________________________________________________________________________________________________________
SFOGLIA UN’ANTEPRIMA DELLA RIVISTA