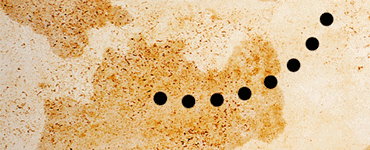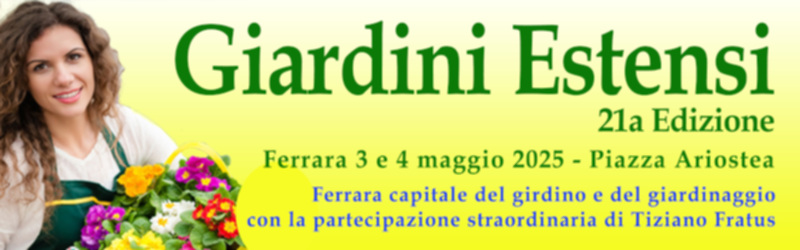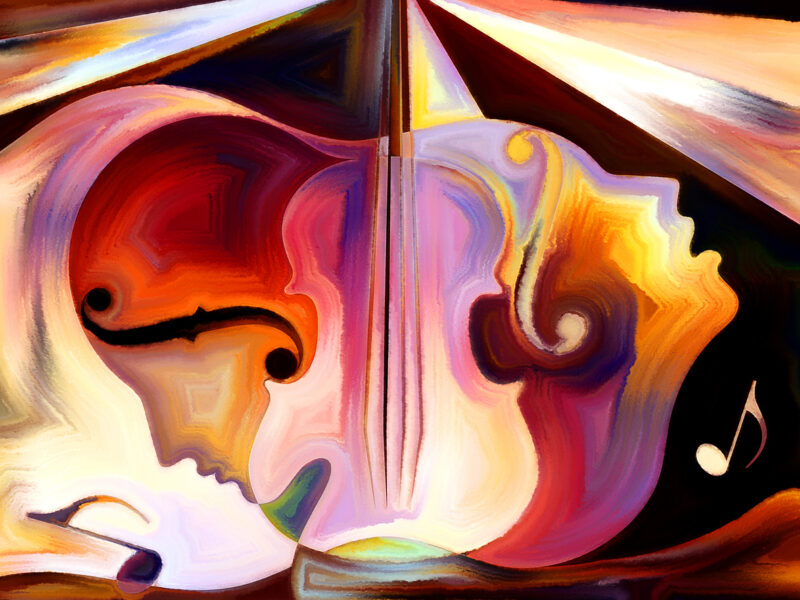Per agroecologia si intende l’ecologia applicata ai sistemi agricoli. Nell’economia agricola liberista si usa per indicare le tecniche di «inverdimento» dell’agroindustria, come il «greening» nell’ambito della Politica agricola comunitaria (Pac).
La bellezza dell’agroecologia contadina
Lo scopo è essenzialmente quello di adattare alcuni aspetti dell’agroindustria alle nuove esigenze, senza modificarne però la sua struttura economico-sociale e il suo impatto sui territori. A tutto questo si contrappongono i gruppi di contadini che nel mondo costituiscono La Via Campesina, movimento internazionale che ha come obiettivo quello di favorire politiche alimentari e agricole più eque, sostenibili e solidali. Essi riconoscono nel concetto di agroecologia una serie di pratiche radicali che rappresentano delle reali alternative alle varie forme di capitalismo verde e alla logica di mercificazione della natura.
Il Coordinamento europeo Via Campesina (Ecvc) inserisce l’agroecologia nell’ambito della sovranità alimentare intesa come «il diritto dei popoli a un’alimentazione sana, nel rispetto delle culture, prodotta con metodi sostenibili e rispettosi dell’ambiente, dove ogni popolo definisce il proprio sistema alimentare e agricolo».
L’agroecologia è quindi connessa alla sovranità alimentare, e ambedue sono strumenti di trasformazione sociale che donano nuova centralità ai sistemi contadini. Secondo l’Ecvc, l’agroecologia agisce su tre piani. Il primo è quello agronomico, che non si basa su ricette precostituite, ma si fonda sui saperi locali per assicurare la vita degli agroecosistemi (suolo, acqua, biodiversità animale e vegetale) attraverso una pluralità di metodi quali le tecniche tradizionali, la policoltura, la permacultura, l’agricoltura biologica e biodinamica, l’agroforestale, le reti di sementi contadine e così via.
Per questo, i saperi contadini vanno riconosciuti al pari delle conoscenze scientifiche accademiche, modificando metodi e obiettivi della ricerca istituzionale attuale, ancora orientata e condizionata dagli interessi del sistema agroindustriale.
Il secondo piano è quello socio-economico, che inserisce il primo dentro percorsi di trasformazione e distribuzione locale dei prodotti della terra, con modalità che favoriscono anche il ruolo delle donne e il ritorno dei giovani all’agricoltura, nell’ambito di un nuovo rapporto tra città e campagna. In questo modo ci si apre alla terza dimensione, quella culturale e politica, nell’orizzonte della giustizia sociale e della solidarietà, con percorsi alternativi alla competizione e alla concorrenza, quali i sistemi di garanzia partecipativa e le reti locali di produzione e consumo, espressioni di nuove forme di azione collettiva.