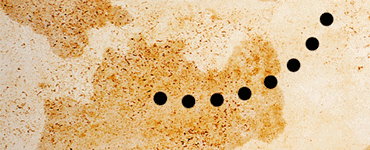Il conflitto come opportunità
homepage h2
di Arnold Mindell
pp. 381 – € 15.00
(per gli abbonati €13.50 )
Sono a Denver nel Colorado, è il 18 Aprile 2011, sarò qui una settimana per partecipare alla ventesima edizione del Worldwork, un seminario internazionale, in cui più di 300 persone provenienti da oltre trenta nazionalità si incontrano per indagare assieme varie problematiche sociali, ambientali e culturali, e allo stesso tempo la propria persona, secondo i principi della democrazia profonda e della psicologia orientata al processo. Si tratta di un’innovativa metodologia ideata da Arnold e Amy Mindell sul finire degli anni settanta, basata sull’idea che la soluzione a un determinato problema, individuale e collettivo sia contenuta nel disturbo stesso il cui processo necessita di essere esplorato. Per l’occasione ho la possibilità di intervistare i due coniugi.
E’ un piacere e un onore per me poter realizzare quest’intervista con voi. Prima di iniziare però vorrei condividere lo stato d’animo in cui sono in questo momento. Avverto una profonda insicurezza in me stesso nell’accingermi a intervistarvi e sono quasi sul punto di trattenermi dal farlo. Temo di non essere all’altezza, di non essere bravo abbastanza per realizzarla. Ma poi mi dico “in questi giorni stiamo parlando di Deep Democracy, sentirmi insicuro è in questo momento il mio processo quindi porterò nell’intervista questa parte di me, senza nasconderla. Come pratica di democrazia profonda.”
Amy: Ottimo. E’ bello che tu possa portare questo in un’intervista.
Arnold: Nessuno di noi è bravo abbastanza. E soprattutto quando si tratta di parlare in pubblico e di farlo in merito ai processi di gruppo e alle questioni globali. Ma ognuno fa quel poco che gli compete, quel poco che può.
Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario del Worldwork: permettetemi quindi di iniziare chiedendovi quali sono le sue origini, qual’è stato il primo impulso che ha dato vita a quest’esperienza.
Arnold: Il primo impulso è stato quando avevo 5 anni e mi sono trovato coinvolto in alcune lotte di strada nelle quali alcuni ragazzi erano cosi arrabbiati con me da essere quasi intenzionati a uccidermi, semplicemente perché io in quanto ebreo non ero della loro stessa razza e religione. A quel tempo (era il periodo della seconda guerra mondiale) nessuno mi aveva insegnato come trattare con questo tipo di esperienze. Avrei voluto che ci fosse qualcuno lì ad aiutarmi. Per trentacinque anni ho represso questi eventi traumatici a tal punto che neppure durante l’intero periodo della mia analisi junghiana è mai emerso nulla. Nemmeno nei sogni. Niente. Così a un certo punto ho pensato: la psicologia va bene, è estremamente importante per fare un lavoro su di se, ma adesso è giunto il momento di portare tutto questo fuori, di portare il lavoro psicologico in pubblico, nelle aree dove è presente una forte tensione sociale. Quell’idea, quel desiderio di apportare sollievo in un contesto pubblico facendo emergere la vita interiore delle persone, i lori sentimenti e le loro motivazioni più intime è stato quello il primo impulso.
Di che anno stiamo parlando?
Arnold: Il primo processo di gruppo con cui abbiamo iniziato a sperimentare è stato nel 1977 o 1978.
In che modo si è strutturata la prima esperienza di questo tipo? Hai chiesto ad alcune persone di unirsi a te per formare un gruppo di lavoro su queste cose?
Arnold: Si ho riunito un po’ di persone di differenti nazionalità, razza, sesso, orientamento sessuale, religioso, politico, classe sociale, professione, ecc.. con l’intento di affrontare qualunque cosa passasse loro per la mente. E woof! appena abbiamo iniziato, tutti erano sconvolti. I miei insegnanti mi dicevano: “Non vorrai mica metterti in quel casino? Avrai troppi problemi. Lascia stare.” e come ho detto qui in questi giorni, i miei insegnanti avevano terribilmente ragione, ma quei problemi sono i problemi del nostro mondo ed è necessario che li affrontiamo. E’ necessario che impariamo a lavorare interiormente su problematiche pubbliche e viceversa portare nei nostri processi interiori la consapevolezza di ciò che accade nel mondo.
Amy: Conosco Arnold da tanto e ricordo che all’inizio lui faceva un lavoro individuale con le persone, poi ha iniziato a lavorare con le coppie e le famiglie e a un certo punto – eravamo in un periodo di forti tensioni razziali e religiose e la gente veniva uccisa per strada – sentivamo sempre più forte la necessità di verificare quanto lontano la psicologia fosse in grado di spingersi nell’affrontare queste forti tensioni sociali. Credo sia stato quello il primo impulso.
Il desiderio di portare la psicologia un po’ più in la del lavoro su se stessi, li dove ci si trova ad affrontare situazioni difficili e non sappiamo come comportarci.
Qual è stata la reazione che avete incontrato nelle persone quando avete iniziato a proporre questo particolare approccio?
Arnold: Molta gente era interessata e voleva sperimentare in tal senso. E, allo stesso tempo, io ho dovuto imparare mentre ero nel mezzo, qual’era il giusto modo di agire. Restando seduto nel fuoco delle difficoltà ho potuto scoprire cosa era d’aiuto e cosa non lo era. Esattamente come il primo essere umano che ha imparato a costruire un martello con la pietra. Vivi l’esperienza e attraverso essa sviluppi le idee necessarie per procedere oltre.
Trovo molto bello questo. Mi tocca sentirti raccontare del modo in cui hai iniziato. La mia domanda successiva si riferisce al tuo libro “Essere nel fuoco“, che hai scritto più di quindici anni fa e di recente è stato tradotto e pubblicato anche in Italia. Un libro pionieristico e di estrema attualità, che ci trasmette non solo le idee alla base del tuo lavoro, ma anche e soprattutto la tua esperienza nella risoluzione dei conflitti con gruppi anche molto numerosi, in tanti luoghi diversi del mondo. Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?
Arnold: All’epoca esistevano già molte informazioni sulla risoluzione dei conflitti, ma la maggior parte di esse era basata sostanzialmente sull’idea che bisogna essere gentili gli uni con gli altri, utilizzando metodi di comunicazione non violenta, oppure incontrarsi in piccoli gruppi di persone che sono d’accordo a parlarsi gli uni con gli altri, ecc… Non esisteva veramente nulla che dicesse “proviamo a incontrarci con le persone senza trasferirgli il messaggio che devono comportarsi bene, proviamo a incontrarci e fare qualcosa persino con coloro che desiderano ammazzarsi a vicenda, che non hanno nessuna intenzione di fare un lavoro su se stessi, e non sono neppure d’accordo a lasciarci partecipare ai loro incontri. Proviamo a parlare con loro.” Non vi era niente del genere. Quindi “Essere nel fuoco” è un tentativo di aprire un varco in questa direzione per sostenere coloro che si ritrovano ad affrontare severe tensioni e conflitti.
Hai iniziato a scrivere questo libro dopo la prima esperienza di Worldwork? Oppure avevi già cominciato prima?
Arnold: No. Ho atteso almeno dieci anni prima di scrivere qualcosa. Ho voluto verificare che questo approccio funzionasse con almeno dieci mila persona. Altrimenti non ci avrei creduto. E appena ho raggiunto questo numero mi sono detto: “Vale la pena di tentare”. Sono molto cauto con i metodi. Quest’attitudine viene dal mio background scientifico. Non mi fido di qualcosa che ha funzionato una sola volta.
Finora di quante persone è stato composto il gruppo più ampio con cui hai lavorato?
Arnold: Ho lavorato con grosse organizzazioni composte a volte anche da più di mille persone.
Trovo che il vostro sia un lavoro a tutt’oggi pionieristico. Intendo dire che è piuttosto raro trovarsi all’interno di dibattiti pubblici, incontri di gruppo, forum cittadini nei quali vengono applicate simili metodiche. Perché ancora oggi è così difficile che questo accada?
Arnold: Perché siamo ancora all’asilo (ride). Non abbiamo modelli che ci insegnino a trattare con il caos della molteplicità. Tutti siamo spaventati dal conflitto. Preferiamo andare in guerra, preferiamo uccidere, piuttosto che urlare, confrontarci e tirare fuori le problematiche. E’ più facile avere un esercito, e spendere un sacco di soldi in armi, e uccidere tanta gente, è molto più facile che andare dal nemico e parlarci, aprire un confronto anche conflittuale con lui.
Sarebbe più economico parlarci ma le persone non hanno alcuna educazione in merito, nessun modello di riferimento su come relazionarsi nelle situazioni difficili, nelle situazioni estreme.
In un certo senso è come se fossimo ancora dei bambini in fase di apprendimento alla convivenza…
Arnold: Si, piccoli bambini. Neonati. Quando giungiamo al conflitto sembra che abbiamo grandi leader o abbiamo avuto grandi leader, grandi peacemaker, ma non è così. Ciò di cui oggi abbiamo maggiormente bisogno è di facilitatori, piuttosto che nuovi leader. Sono convinto che il prossimo salto nell’evoluzione umana sarà quello in cui ognuno imparerà a essere un facilitatore, imparerà come facilitare il proprio processo e quello altrui. I prossimi grandi leader saranno facilitatori.
Come avete più volte sostenuto in questi giorni il facilitatore non è solo una figura professionale che ha studiato per esserlo. Spesso il facilitatore può emergere in ognuno di noi nelle situazioni più impensate, e anche in coloro da cui meno ce l’ho saremmo aspettato.
Amy: Esattamente. Ci piace la definizione di partecipante/facilitatore. Può darsi che un insegnante sia li a condurre una classe, e all’improvviso dal gruppo emerge qualcuno con una prospettiva diversa in grado di apportare maggiore comprensione a ciò che accade, alle parti coinvolte nel conflitto.
E’ importante notare queste figure e sostenerle nel processo di gruppo, perché sono in grado di apportare rapide trasformazioni positive.
Nel vostro lavoro voi parlate spesso del processo del sognare e dei modi in cui è utile esplorare tale processo per poter creare comunità sostenibili. Potete spiegare cos’è questo processo del sognare a qualcuno che non ha familiarità con questo tipo di terminologia e metodologia?
Arnold: Certo. Facciamo un esempio. Durante la sessione di oggi abbiamo visto il gruppo di persone dell’America latina lavorare assieme su questioni riguardanti la criminalità, le droghe… Queste persone si sono incontrate qui per la prima volta. Come hanno iniziato a parlare, alcune delle questioni più importanti sono subito emerse: il grosso problema dei traffici di droga, il nord che vuol mantenere povere le persone, si è parlato di gangster, criminalità, suicidi. Ovviamente si tratta di questioni reali, ma allo stesso tempo, nel momento in cui cominciamo a parlarne, diventano ruoli, fantasmi sospesi nell’aria. Si presentano alla coscienza come se fossero un sogno collettivo che può essere processato dal gruppo allo stesso modo in cui avviene nella terapia individuale, quando un paziente lavora su un proprio sogno e comincia ad appropriarsi dei significati che questo contiene. Avviene la stessa cosa qui nel gruppo: nel momento in cui viene nominato il problema della droga e qualcuno incarna la persona tossicodipendente in una sorta di gioco di ruolo, quell’elemento ha la possibilità di esprimersi, di avere voce a beneficio dell’intero gruppo. All’improvviso il gruppo si illumina: “Si! Quella persona, con quei problemi terribili, ci riguarda, siamo noi!” Quindi attraverso l’esperienza del sognare insieme, il gruppo acquisisce una percezione più ampia di se e si sente più a casa. Questo ovviamente è solo un esempio.
Vuoi aggiungere qualcosa anche te Amy? So che questo è un tema che ti sta molto a cuore.
Amy: Sognare è qualcosa che in tutti i tempi e le culture è da sempre avvenuto. Attraverso il teatro, l’arte, il rito, l’essere umano ha espresso sempre la propria necessità di andare più in profondità, alla ricerca di un livello di percezione essenziale delle cose e dei fenomeni. Per meglio comprendere cosa muove le persone e ciò che accade tra di esse. E, a un livello più pratico, visto che tu ci hai domandato di rivolgere la risposta a chi non è addetto ai lavori, facciamo un esempio. Nel nostro lavoro noi diciamo di notare i doppi segnali, che come i sogni, veicolano elementi essenziali della comunicazione inconscia tra due o più persone. Quindi mettiamo che due persone stiano cercando di fare una trattativa e giungono a un accordo. Mentre i due si stringono la mano, proprio in quel momento uno di loro si gira a guardare da un’altra parte come se fosse attratto da qualcos’altro. Se non ci soffermiamo su questo sogno cercando di portare quel qualcosa nel processo della comunicazione, probabilmente la loro trattativa non durerà a lungo seppure entrambe abbiano detto si. E’ una questione molto pratica.
E quindi in che modo voi affrontereste una situazione simile?
Arnold: Io ti direi: “forse una parte di te non desidera giungere ad un accordo ancora. Se c’è qualcosa che non ti convince del tutto per favore affrontiamo la questione adesso. Non comportiamoci come se tra di noi fosse tutto apposto se poi una volta usciti da questa stanza tu desideri fare guerra nuovamente. Risparmieremo tempo ed energie. Proviamo ad avere più conflitto adesso, tra di noi, nella stanza, senza ucciderci a vicenda dopo.”
Sentirti dire queste cose ha su di me un effetto liberatorio. Ma è proprio questa la difficoltà, talvolta abbiamo troppa paura di affrontare i doppi segnali, abbiamo troppa paura di quello che potrebbe emergere affrontando direttamente un conflitto. E’ per questo che preferiamo, consapevolmente o meno, tenere nascoste le cose.
Arnold: In una situazione simile allora ti direi: “Mi sento un po’ a disagio nel conflitto e non mi piace tanto parlarne, ma se non ti dispiace, vorrei chiederti se c’è qualcosa che ti disturba o che non ti permette di essere ancora del tutto disposto a riappacificarti in questo momento.
Spesso nelle dinamiche di gruppo quando qualcuno esprime dissenso sia in termini di opinione differente o manifestando emozioni sgradite al leader e alla maggioranza del gruppo, la voce, l’esperienza di quella persona può essere facilmente marginalizzata e talvolta bruscamente esclusa.
E’ facile parlare dell’importanza di apprezzare la diversità, ma quando qualcuno la incarna davvero ci sentiamo disturbati o spaventati e vorremmo reprimerla. Come possiamo trovare una nuova attitudine dinanzi a queste esperienze, che ci permetta di imparare qualcosa da esse e uscirne arricchiti?
Arnold: Sia come facilitatore, che come partecipante proverei a riconoscere e onorare l’importanza dei due o più punti di vista. Riconoscendo le differenze di rango sociale e spirituale tra le varie parti. Se la persona che è in disaccordo con il leader ha paura di esprimersi ulteriormente, potrei utilizzare me stesso come modello per dare voce a ciò che io immagino quella persona intende dire.
Se a quel punto il leader dovesse non essere d’accordo con me, io cercherei di dare voce a entrambi i punti di vista, modellandoli nella mia espressione in una sorta di gioco di ruoli, fino a sentire che le due parti sono giunte ad una risoluzione, oppure fino a che le due persone non sono in grado di sostenere e continuare da sole il loro dialogo. Questa è l’arte del processwork, ma non è qualcosa che può essere facilmente detto in parole o immaginato senza averne fatto esperienza.
Ancora un paio di domande e poi vi lascio andare. Ho un’amica che lavora nel campo psichiatrico come educatrice. Lei prova molta sofferenza nel constatare quotidianamente come le persone vengano diagnosticate sulla base di brevi colloqui oppure su una base esclusivamente organica, senza tenere minimamente in considerazione la “storia” che quella persona porta con se. Trovo che questo sia abusivo, poiché chi si trova nella posizione di medico ha un potere enorme sul paziente. E la tendenza della psichiatria internazionale va nella direzione di trattare questi “processi” scegliendo la via più facile, vale a dire quella farmacologica. Cosa pensate in merito? Quali sono secondo voi i motivi di questa tendenza?
Arnold: Qui in America diverse persone parlano dell’utilizzo inconsapevole dei farmaci e del potere medico della psichiatria, in termini di abuso psichiatrico. Quello che intendono dire con ciò è che i medici spesso sono spaventati, oppure non sanno come interagire dinanzi a qualcuno che si trova in un insolito stato di coscienza. Quindi, si lo penso anche io che la psichiatria possa essere abusiva. Credo che i medici abbiano bisogno di maggior training. L’uso dei farmaci va bene, in alcuni casi può essere appropriato e di grande aiuto, ma, se i farmaci vengono utilizzati per marginalizzare l’esperienza e la storia della persona qualcosa rimane sullo sfondo e alcune persone si sentiranno molto ferite da ciò. Quindi, io dico ok usate i farmaci se funzionano e la comunità medica deve apprendere come utilizzarli in maniera adeguata e allo stesso tempo ha bisogno di apprendere come parlare alla persona, come porsi in ascolto della storia, come giocare, come interagire.
Voi spesso quando parlate di psicologia o di psichiatria fate riferimento alla dimensione politica, al rapporto esistente tra gli stati interiori e la comunità di cui volenti o nolenti facciamo parte.
Arnold: Frequentemente, quasi sempre, ma lasciami dire di frequente per essere conservatore, la persona in un insolito stato di coscienza si trova lì in parte per il fatto che la comunità non sta sperimentando quello stato, perché lo proibisce o lo reprime. Ad esempio con la paura, la paura degli altri, o con la paranoia, con la depressione. A questi stati non viene concessa adeguata attenzione nella dimensione pubblica.
Amy: Penso che sicuramente conosci il libro di Arnold su questi argomenti “City shadows” nel quale viene esposta l’idea che le persone che si trovano in alcuni stati di coscienza estremi a volte, o di frequente, esse rappresentano ciò che la loro comunità (famiglia o intera città che sia) è restia ad affrontare: qualcosa che vuole emergere ed essere integrato, fare parte di quella comunità.
Potrebbe essere questo uno degli esempi di democrazia profonda di cui spesso parlate?
Arnold: Si. Democrazia profonda vuol dire affrontare la realtà cosi com’è, poi includere il sognare, i doppi segnali di cui parlavamo prima e quei profondi stati di coscienza come la paura, l’amore, il panico, il bisogno estremo. Portando tutto ciò maggiormente in pubblico, questo forse potrà aiutare indirettamente molte persone che soffrono a causa di questi stati emotivi.
Mi infonde un senso di speranza sentirvi dire queste cose, e mi aiuta a comprendere meglio questi processi. Grazie Arnold, Grazie Amy. E’ stato un privilegio per me potervi porre queste domande.
Arnold e Amy: Grazie a te per averlo fatto, lo abbiamo apprezzato. Grazie!
Per chi vuole approfondire l’argomento, dal 28 al 30 aprile 2012 a Zurigo si terrà la conferenza Global Change: social tension, crisis and the process of transformation con Arnold Mindell e altri relatori.
Per informazioni: lettere@aamterranuova.it – giuseppeanimamundi@gmail.com
Per maggiori informazioni sulla metodologia, le aree di applicazione, e i seminari di studio in europa: giuseppeanimamundi@gmail.com
Articolo tratto da Terra Nuova – Novembre 2011 disponibile anche come eBook.
La nostra rivista: TERRA NUOVA
Acquista l’ultimo numero della rivista
Leggi on line la copia omaggio integrale della nostra rivista