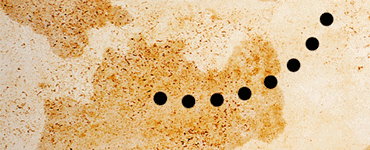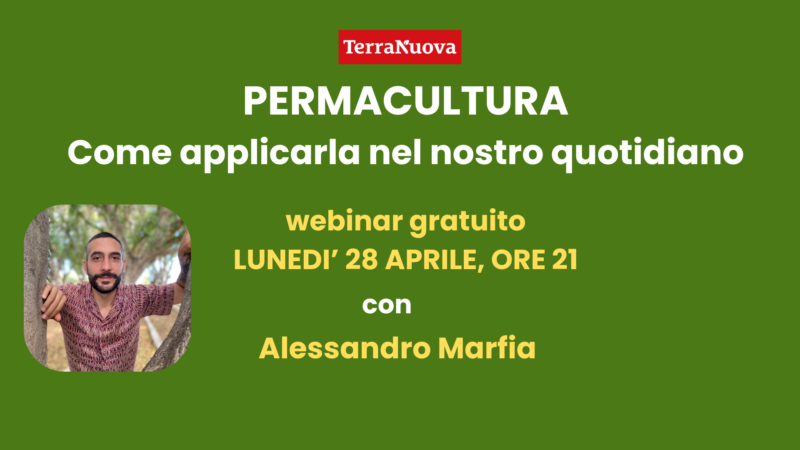Elena è italiana ma ha vissuto in Inghilterra per sette anni; ora torna con la famiglia in Italia, si stanno trasferendo in un casolare nella campagna modenese. «Io sono italiana – racconta a Terra Nuova – mio marito ha passaporto britannico e israeliano, è nato in Francia ma cresciuto in Israele e ci siamo conosciuti al Cairo in una scuola di lingua araba. Un bel mix! Siamo entrambi sensibili da sempre alle tematiche ambientali e a quelle dell’integrazione culturale ma da quando siamo diventati genitori questa sensibilità si è fatta più acuta e abbiamo cominciato a mettere in discussione attivamente molte delle nostre abitudini e delle nostre presunte necessità».
Come è presto detto. «Io ho abbandonato la ricerca accademica e mi sono dedicata a fare la mamma a tempo pieno. I nostri bimbi non vanno a scuola ma stanno seguendo un percorso di apprendimento auto-diretto a casa, in cui noi genitori agiamo come mentori e facilitatori. Non abbiamo mai avuto televisione ma abbiamo una sovrabbondanza di libri. A gennaio 2016 abbiamo deciso di accettare la sfida a
produrre la minor quantità di rifiuti domestici possibile, specialmente plastica.
Abbiamo venduto la macchina e ci spostiamo soprattutto in bici: oltre alle nostre bici classiche abbiamo due bici cargo, una a pedalata assistita con il cassone davanti e due sedili per il trasporto dei bimbi, e una pieghevole con seggiolino posteriore allungato per permetterci di muoverci anche caricando bimbi e bici in treno».
«Abbiamo venduto anche la nostra casa in Inghilterra per comprare un vecchio casolare con un grande giardino nella campagna modenese, vicino alla mia famiglia di origine – continua Elena – Mio marito sta terminando il suo contratto da ricercatore in elettrochimica e insieme vorremmo realizzare qualcosa che sia più in linea col nostro desiderio di connessione, tra di noi in famiglia e con l’ambiente naturale e sociale che ci circonda. Vorremmo restaurare il casale riducendone al minimo l’impatto ambientale soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, magari con una stufa in muratura, e affiancando anche un sistema di recupero delle acque piovane. Invece di apparecchi elettrici vorremmo, dove possibile, optare per alternative manuali o a impatto ridotto: vogliamo riprenderci l’uso delle mani e del nostro corpo e restituire loro dignità. Una lavatrice-bicicletta, un mulino manuale per la farina, un forno solare, un essiccatore solare per conservare i cibi attraverso la disidratazione, la falce al posto del tagliaerba: le idee sono tante, l’esperienza ancora poca ma come diceva il titolo di quel libro “Io speriamo che me la cavo”. Il mio sogno poi sarebbe di ricreare intorno al casolare una foresta giardino commestibile seguendo il modello dell’Edible Forest Garden di Robert Hart e Martin Crawford in Inghilterra e di Dave Jacke e Eric Toensmeier negli Stati Uniti, ma è un progetto di lungo termine e almeno all’inizio punteremo invece a preparare un piccolo orto in permacoltura».
«Ci piacerebbe trasformare il casolare in un piccolo centro culturale che promuova una maggiore consapevolezza ambientale, lo scambio linguistico e culturale che è nella storia della nostra famiglia, ma anche il recupero delle tradizioni di artigianato locale. In particolare, in Inghilterra mi sono appassionata all’arte della filatura e della tessitura, ancora molto vive nel mondo anglosassone, e mi piacerebbe far rivivere la tradizione locale della lavorazione della lana e soprattutto della canapa. L’idea di base però sarebbe quella di renderci il più possibile autosufficienti così da ridurre la nostra dipendenza dall’economia monetaria e dalla necessità di guadagnare. Servirà tempo e sarà un percorso in salita, ma siamo convinti che la semplicità volontaria sia la strada per la felicità».
Da dove è partita questa scelta? Cosa vi ha motivato e come è nata in voi la sensibilità nei confronti dell’ambiente e delle scelte di vita quotidiane all’insegna del basso impatto? E come mai avete deciso di ampliare la scelta a largo raggio, fino all’educazione a casa?
«La sensibilità nei confronti dell’ambiente me la porto dietro da quando ero bambina, ero socia Junior del WWF e insistevo a scrivere con la penna stilografica ricaricabile per non avere biro da buttare; poi ai tempi dell’Università ero rimasta molto colpita dall’esperienza dei Bilanci di Giustizia e dal nuovo modello di sviluppo di Francuccio Gesualdi. La svolta però è arrivata con la nascita della nostra primogenita. Eravamo arrivati in Inghilterra da due mesi, da soli, con due valigie in mano e un budget decisamente limitato visto che mio marito frequentava un master e contavamo solo sui nostri risparmi. Da sempre restii all’acquisto di gadget inutili, volevamo prenderci cura al meglio della nostra bambina, con attenzione e rispetto, ma senza sprechi e senza dimenticare l’ambiente in cui sarebbe cresciuta».
«Di cosa ha bisogno davvero un neonato e di cosa invece può fare serenamente a meno? Ha bisogno di nutrimento, di essere protetto dagli elementi, di vicinanza, di rassicurazione, di rispetto e di affetto, proprio come tutti noi; ma non serve spendere una fortuna per rispondere a queste necessità, anzi la risposta più istintiva ed ecologica è anche quella più economica e rispettosa delle esigenze della piccola. Per noi fare meglio con meno ha significato allattamento al seno a richiesta, proseguito fino ai due anni; co-sleeping; pannolini lavabili; autosvezzamento; un ricorso sereno e quasi continuo alla fascia porta-bebè. Non nego che a volte sia stato faticoso, ma sono convinta che il guadagno in termini di benessere per il bimbo e per i genitori valga bene la fatica. In tutto ciò ha avuto un ruolo importante il supporto che abbiamo ricevuto in Inghilterra e che ci ha permesso di vivere un’esperienza di nascita molto bella e naturale, sebbene fossimo in ospedale, e un buon avvio dell’allattamento. La lontananza dalle famiglie di origine è stata pesante, ma ci aiutato a riconoscere e a prendere le distanze dalle convenzioni sociali e dalle abitudini che normalmente tendiamo a mantenere senza chiederci perché. Questo è stato l’inizio di un percorso di riflessione che ci ha portato a mettere in discussione in maniera piuttosto radicale tante opzioni che ci vengono presentate come ovvie dalla nostra società ma che a ben vedere sono discutibili».
«La riflessione critica si è allargata a cascata. Ha coinvolto la nostra dipendenza dal petrolio e dai circuiti del consumismo, dall’economia monetaria e dal lavoro salariato, la nostra sconnessione dal cibo che mangiamo, dagli abiti che indossiamo e dalla terra che calpestiamo e che ci nutre. Si è tradotta nella riscoperta di quella che Ivan Illich chiama “convivialità”, ossia quella forma di libertà individuale che si realizza nella consapevolezza dell’interdipendenza tra le persone e con l’ambiente e dalla cui carenza deriva spesso quel senso di frustrazione, alienazione e profonda infelicità che caratterizza la società industriale».
«La scelta di non iscrivere i nostri figli a scuola si inserisce in questo filone: il rifiuto di delegare e relegare l’educazione dei bambini in un ambiente istituzionalizzato, in cui cosa, come e quando si impara vengono decisi dall’alto. L’apprendimento auto-diretto che cerchiamo invece di incoraggiare è un’assunzione di responsabilità, un tentativo di favorire la liberazione delle energie fisiche, creative, emotive e spirituali dei bambini; è una scelta di fiducia nella loro innata capacità di di imparare, di rispetto delle loro inclinazioni, dei loro interessi e dei loro percorsi di maturazione individuali. John Holt è stato l’autore che più ci ha fatto riflettere sulla straordinaria capacità dei bambini di assorbire e rielaborare autonomamente le esperienze vissute; Ivan Illich e il documentario Schooling the World ci hanno rassicurato sulla validità di una scelta che molti etichettano come privatistica, ma che noi definiremmo più come rivoluzionaria. In fondo, per cambiare una cultura in una generazione basta cambiare il modo in cui sono educati i bambini».
Come si svolgono materialmente le vostre giornate? Quali difficoltà avete incontrato all’inizio e quali non avete ancora del tutto superato?
«Le nostre giornate si svolgono più o meno come si svolgerebbero le giornate estive di una famiglia in cui uno dei genitori è a casa. A volte si va fuori, per una passeggiata, un giro al parco, in biblioteca, in qualche museo, oppure alla fattoria didattica; a volte si resta a casa, ci si aiuta nelle faccende domestiche, si legge un libro (o due, o tre!). I bimbi hanno sempre a disposizione colori e fogli per disegnare, libri da sfogliare, qualche gioco, la palla, le bici, vestiti per travestirsi; le lezioni di nuoto e di violino e la spesa settimanale al mercato dei contadini sono gli unici impegni fissi, il resto dipende molto dall’umore e dal tempo atmosferico. Si parla senza censure di tutto quello che suscita la curiosità dei bambini: dalle elezioni di Trump alle abitudini alimentari degli antichi Romani, dall’estinzione dei dinosauri alla riproduzione sessuale. I bimbi vengono anche coinvolti, per quanto possibile, nelle nostre attività: cucinare, preparare la birra, filare e tessere, prenderci cura del giardino».
«La difficoltà maggiore è stata la mancanza di quel villaggio che il proverbio africano dice sia necessario per fare crescere un bambino. La solitudine e la mancanza di supporto esterno nei momenti di difficoltà, di crisi e di malattia hanno pesato molto soprattutto su di me, che ero le parte più attivamente coinvolta nella gestione domestica e dei bimbi. Siamo entrati in crisi anche come coppia, e ho fronteggiato l’abisso cupo della depressione post parto con l’ultimo bimbo. Abbiamo capito che dovevamo rivedere in profondità le nostre dinamiche famigliari, che non erano più adeguate ad accomodare le scelte che stavamo portando avanti: anche da qui è partita la decisione di rientrare in Italia, vicino a una delle due famiglie allargate, e avviare un progetto nuovo, insieme».
Come vi vedono gli altri? Giudizi? Critiche? Solidarietà?
«Un po’ di tutto! Credo soprattutto molta perplessità: non è facile uscire dai soliti schemi. Il nostro impegno per l’ambiente viene spesso deriso come una goccia nel mare; la rinuncia all’automobile viene considerata una deprivazione; l’abbandono della carriera accademica come una pazzia; il ritorno a forme di vita più semplici come un’anacronismo. La scelta di non mandare i bimbi a scuola è quella che in genere suscita le reazioni più allarmate, anche da parte delle nostre famiglie: su questo c’è molta incomprensione, nonostante i nostri tentativi di spiegare. Ormai però abbiamo abbracciato il nostro anticonformismo e non temiamo di essere visti come una famiglia “strana”».
«Dall’altra parte, queste scelte ci hanno messo in contatto con tante persone che condividono le nostre idee, o almeno alcune, e da parte loro c’è stata tantissima solidarietà: reti di famiglie che non iscrivono i bimbi a scuola, individui, famiglie e piccole comunità che si impegnano per l’ambiente e con cui ci si sostiene a vicenda».
Come hanno reagito i vostri figli? E come pensate di fare quando saranno più grandi?
«Come genitori, che lo vogliamo o no, trasmettiamo ai nostri figli quella che è la nostra cultura famigliare: ogni decisione è una dichiarazione di valori, ogni soldo che spendiamo, ogni minuto che dedichiamo a un’attività piuttosto che a un’altra. Come ci si relaziona, come si celebra, come si reagisce alle crisi, come si stabiliscono le regole e come si reagisce quando le regole vengono infrante, come si organizzano gli spazi: tutto manda un messaggio potente su chi siamo e a cosa diamo valore. In famiglia cerchiamo di riflettere con consapevolezza sui valori dietro le scelte quotidiane: non sempre siamo coerenti, ma ci proviamo e quando non ci riusciamo lo riconosciamo più serenamente possibile».
«I bambini sono cresciuti nella nostra cultura famigliare: guardano documentari con noi, leggono con noi, ascoltano le nostre conversazioni e si impegnano con noi. Sanno che siamo diversi da tante altre famiglie, ma sanno anche perché e spesso cercano di convincere i loro amichetti e le famiglie allargate a usare meno la macchina, a non portarsi a casa rifiuti con la spesa. I due più piccoli sono agguerriti contro la plastica, la raccolgono quando la vedono per terra, la indicano con orrore quando la vediamo nei negozi; la più grande si chiede perché a tante persone non interessa l’ambiente in cui vivono e non lo rispettano. Noi non facciamo pressioni ma condividiamo le nostre preoccupazioni e le nostre speranze con loro».
«Qualcuno ci ha detto che è un lavaggio del cervello; per noi è la trasmissione di ideali che crediamo ci rendano più felici. Un lavaggio del cervello ben più grave e insidioso ci sembra sia quello promosso da certi programmi in televisione, dalla moda, dal continuo bombardamento di inviti a consumare della pubblicità, dalle notizie economiche che ci illudono che la situazione sia tanto più rosea quanto più sperperiamo. Questi messaggi generano infelicità, alimentano l’alienazione, sono bugie. Ivan Illich sosteneva che addirittura la scuola fosse un’agenzia pubblicitaria che ci porta a credere che abbiamo bisogno della società esattamente come è. Per quanto ci riguarda, continueremo a condividere le nostre riflessioni con i bambini anche quando saranno più grandi: senza imposizioni, saranno progressivamente più liberi di affrontare decisioni indipendentemente da noi ma crediamo che alimentare il loro spirito critico fin da ora sia una buona vitamina».
Un messaggio a chi dice: io non ce la farei mai.
«Lo pensavo anche io: bello, stupendo, ma io non ce la farei mai. La pensavo così anche quando ho ricominciato a correre dopo la nascita della mia seconda figlia: mio marito correva 21 km senza apparente sforzo e io ansimavo a percorrerne due. Quando mi sono accorta che, a forza di provare e riprovare, per quei due chilometri non ansimavo più, i chilometri sono diventati tre, poi cinque, poi otto, poi dieci. Quest’anno, incredula e soddisfatta, ho corso la mia prima mezza maratona. Si parte sempre su una distanza breve, una piccola scelta che ci sfidi a vivere più in linea con la vita che vorremmo. Pian piano la fatica scompare, non ci costa più come sembrava all’inizio: e allora si può fare qualcosa in più, aggiungere un altro chilometro. Le scelte, come le gambe, con un po’ di allenamento ci possono portare lontano».