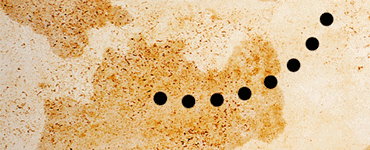Leggi anche
Fegato grasso: l’approccio dell’omeopatia
Il fegato grasso, o steatosi epatica, spesso indica che lo stile di vita e le abitudini alimentari stanno compromettendo un organo fondamentale. L’approccio dell’omeopatia.
Ammorbidenti: i rischi del convenzionale e le alternative ecocompatibili
Gli ammorbidenti che utilizziamo per il bucato in lavatrice possono avere un forte impatto sull’ambiente e sulla nostra pelle, non sempre positivo. Scopriamo insieme come sceglierli.
Il benessere naturale del cane e del gatto
Obesità, allergie, tumori, malattie croniche e autoimmuni. Sono solo alcune delle patologie che sempre più spesso colpiscono i nostri animali da compagnia. Le cause? Alimentazione industriale, abuso di farmaci ed esposizione ad agenti inquinanti. Ecco i suggerimenti degli esperti per invertire la tendenza.
Controllo delle infestanti con la biodinamica
Il problema del controllo delle erbe infestanti è molto in agricoltura, benché molte di esse servano per risanare il suolo. L’agricoltura biodinamica agisce dunque proprio attraverso il risanamento del suolo.
Fegato grasso: l’approccio dell’omeopatia
Il fegato grasso, o steatosi epatica, spesso indica che lo stile di vita e le abitudini alimentari stanno compromettendo un organo fondamentale. L’approccio dell’omeopatia.
Ammorbidenti: i rischi del convenzionale e le alternative ecocompatibili
Gli ammorbidenti che utilizziamo per il bucato in lavatrice possono avere un forte impatto sull’ambiente e sulla nostra pelle, non sempre positivo. Scopriamo insieme come sceglierli.
Il benessere naturale del cane e del gatto
Obesità, allergie, tumori, malattie croniche e autoimmuni. Sono solo alcune delle patologie che sempre più spesso colpiscono i nostri animali da compagnia. Le cause? Alimentazione industriale, abuso di farmaci ed esposizione ad agenti inquinanti. Ecco i suggerimenti degli esperti per invertire la tendenza.
Controllo delle infestanti con la biodinamica
Il problema del controllo delle erbe infestanti è molto in agricoltura, benché molte di esse servano per risanare il suolo. L’agricoltura biodinamica agisce dunque proprio attraverso il risanamento del suolo.