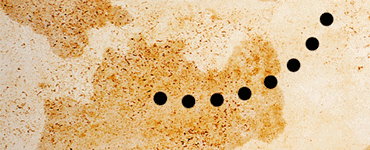La sua ricerca per scardinare i dogmi del vivere e approdare a una visione condivisa del simbolico che ci rappresenti e ci identifichi come donne, proviene da lontano e ha le caratteristiche di un percorso politico che non può prescindere dal lavoro su di sé. Nei suoi saggi, Percovich ripercorre la storia delle donne da un’ottica che riabilita la sacralità del corpo come strumento di liberazione, punto essenziale nella riacquisizione di una spiritualità originaria e di quell’autorità femminile negata dal presente.
Ne abbiamo parlato con lei in un’intervista.
Luciana, ci racconti a grandi linee come è iniziato il tuo percorso?
È iniziato a Milano, dove facevo l’Università: era nell’aria il ’68. Io venivo da una tranquilla cittadina del nord est, Gorizia, e in quel clima di occupazioni universitarie e manifestazioni improvvisamente ci balzò evidente, a me ed altre giovani donne, che anche la specificità femminile poteva essere rimessa in discussione. Come spesso è successo nella mia vita è stato attraverso un libro che ho fatto il salto di coscienza: Patriarcal Attititudes (1), che richiamava l’attenzione sui trattamenti di serie b che venivano riservati alle donne, ma di cui io fino a quel momento non mi ero accorta. Perché i comportamenti discriminatori nei confronti delle donne sono talmente connaturati che li diamo per scontati e li sopportiamo, finché qualcosa non ci dice che invece non sono affatto naturali, come sta avvenendo oggi per esempio nel caso delle molestie sessuali. Fondammo un primo gruppo di autocoscienza, come stava avvenendo non solo in tutta Italia ma in buona parte dell’Occidente, e da lì si innescò una progressiva carica di energia che tutt’ora, 40 anni dopo, non si è ancora esaurita.
Perché si è iniziato con i gruppi di autocoscienza?
I gruppi di autocoscienza erano necessari almeno su due livelli: primo per ritrovarci, dopo migliaia di anni, in gruppi di donne determinate a interrogare le proprie vite, nella scelta della sottrazione dallo sguardo maschile e per dare risposte alla sofferenza che, chi in dosi maggiori, chi in minori, ci portavamo dentro. Fu straordinario accorgerci che tutte vivevamo in maniera simile e che le singole vicende non erano frutto di inadeguatezza o di incapacità personale, ma una condizione comune. Questo innescò un secondo elemento molto importante: quello dell’altra donna che ti fa da specchio.
E in questo contesto come si è sviluppata la pratica del self help?
Una parte del movimento delle donne, a cui ho aderito, ha capito che non aveva senso parlare di sessualità, il grande tema in cui confluivano poi le varie ricerche, senza riprendere contatto con i propri singoli corpi. Quindi la pratica del
self help, cioè dell’autovisita che praticavamo in piccoli gruppi, anche con l’aiuto dello
speculum, serviva per vedere in noi in senso materiale e metaforico. Significava rompere un tabù millenario sulla conoscenza del nostro corpo, in particolare di quelle parti che erano di esclusivo dominio del maschio, che fosse marito, amante o ginecologo. Nella cultura delle nostre madri e nonne spesso non esisteva nemmeno la parola per chiamare gli organi genitali femminili: un tabù, una negazione che rendeva la donna mutilata, perché viveva in un corpo usato e nominato da altri. Il
self help era un gesto molto eversivo. Si svelava il mistero del nostro corpo, vedevamo il collo dell’utero. Non fu una pratica estremamente diffusa, perché spaventava terribilmente la maggior parte delle donne. Voleva dire fare piazza pulita di una quantità di divieti, di attribuzioni culturali, di letture di che cosa è il femminile, di cosa è il mettere la mondo, di cosa è la sessualità, insomma, di tutti quei discorsi in cui noi non avevamo avuto parola negli ultimi 5000 anni.
Come sei arrivata poi da questa riappropriazione del corpo a quella della spiritualità?
Ci è voluto ancora molto tempo. Sull’onda del movimento studentesco e operaio, nel ’68 abbiamo iniziato a rimettere tutto in discussione, compresa la nostra formazione religiosa, attraverso il pensiero marxista, che però fece piazza pulita di tutta la sfera spirituale. Quello che contava erano i fatti, tutto il resto erano ‘favole da vecchiette’. Questa liberazione da un’oppressione che ci era venuta dall’indottrinamento cattolico ha significato però mutilarsi un’altra volta di un aspetto di noi molto importante, che riguarda le domande più profonde sul senso della vita e della morte. Quindi ho iniziato a leggere, ancora una volta i libri sono stati fondamentali, quello che era stato scritto già dall’inizio degli anni ’70 da teologhe e antropologhe. Queste ultime ebbero un ruolo molto importante: erano scese in campo per la prima volta intorno agli anni ’50, mostrando aspetti inediti delle culture indigene dei vari continenti, avendo finalmente accesso alle linee di conoscenza femminili. I lignaggi femminili, spesso interdetti agli uomini, sono quelli più ricchi proprio perché le donne, che danno la vita e accompagnano alla morte, sono più direttamente vicine ai grandi interrogativi dell’essere al mondo. Essi rivelano una sacralità che convive con la vita degli animali e delle piante e quello che ora indichiamo con la parola “spirituale” è il collante che tiene insieme e che genera le azioni sul piano della quotidianità. Nelle società matriarcali ancora esistenti questa visione olistica è evidente. Questo mio percorso, all’inizio molto solitario, mi è sembrato il normale compimento della presa di coscienza cominciata a partire dal corpo: andando sempre più alla radice c’è stata una riappropriazione della dimensione spirituale e del sacro e l’enorme gioia che la accompagna. Purtroppo non da tutte e tutti compresa, in quanto c’è ancora una chiusura molto forte rispetto a questa dimensione. Ho scoperto Merlin Stone, che ha scritto When God was a Woman (2), nel ’76, e poi l’altro bellissimo libro che si chiama Ancient mirrors of womanhood (3), una raccolta di miti da tutti i continenti, dove per la prima volta si parlava di Dee in un’accezione del termine che non era corrispondente a Dio declinato al femminile. Confrontarsi con la parola Dea ha significato rimettere in discussione tutta una serie di significati che sembravano inamovibili. È iniziato a sembrarmi evidente come il concetto di Dio si sia affermato solo ad un certo punto della storia, cioè nel primo millennio a. C. (nell’età del ferro). Questo periodo fu preceduto da circa 3000 anni di grande conflitto e confronto fra la visione olistica femminile, in cui la Dea è nella natura e tutti siamo parte di un unico ciclo che si rinnova periodicamente e l’idea di un Dio sessuato al maschile ma allo stesso tempo senza corpo, cioè trascendente e non più parte del cosmo. Di questo parlo nel mio libro oscure madri splendenti (4). Poi ho conosciuto Marija Gimbutas (5), con la sua rivoluzionaria prospettiva della storia, del concetto di civiltà stesso. Sono entrata in contatto con Joan Marler, che fu la sua collaboratrice negli ultimi dieci anni della vita dell’archeologa. Joan continuava la consuetudine di Marija Gimbutas di organizzare convegni internazionali a rotazione nei vari Paesi europei per mettere a confronto le ricerche dei singoli team di archeologi. Sono andata ad uno di questi, in Bulgaria, dove ho conosciuto tante persone appassionate di questi temi, come per esempio Vicki Noble. Organizzando i primi corsi di Vicki in Italia, c’è stata una risposta molto forte da parte di donne più giovani di noi femministe, con le quali ho iniziato a collaborare e questo mi riempie il cuore di gioia.
Anche perché il recupero del sacro è un grande passo verso l’empowerment…
Il recupero della sacralità femminile è reale impoteramento: se una donna si sente centrata sul suo valore, si sente parte di un tutto molto più vasto e percepisce la propria quotidianità e il proprio corpo come sacri. Richiama in sé la dignità e questo significa esserci, anche nella relazione con gli altri.
Questa capacità di presenza è anche quella che permette alla donna di imporre la propria autorità senza l’uso della violenza?
Si, ma questo passaggio va espresso anche su un piano simbolico. Un tema su cui abbiamo lavorato molto durante il primo periodo del movimento femminista è quello dell’onnipotenza femminile, che maschera l’ impotenza. Infatti, il sentire che comunque dentro di sé si ha una forza e una potenzialità che nessun uomo potrà mai avere, ha finito per essere per molto tempo qualcosa di consolatorio per noi donne, come se ognuna di noi potesse ritirarsi, magari nel colmo dell’infelicità o dell’ingiustizia, in un’isola in cui nessuno la può scalfire. Quindi si, noi possiamo autorappresentarci così, ma finché questo non diventa simbolicamente vero e riconosciuto, non cambia nulla. E credo che una delle più forti acquisizioni del movimento femminista sia stato il lavoro sul tema della madre simbolica. Quando abbiamo capito che il simbolico è altrettanto importante del reale, perché noi siamo animali simbolici, allora c’è stato un salto di qualità.
Cosa ha portato il riconoscimento della madre simbolica?
Ci ha aiutato a riconoscere nell’altra il talento femminile, ossia la capacità di agire la propria visione in un corpo non semplicemente umano, ma sessuato al femminile. Ognuna può esprimerla in ogni campo, sia che faccia l’insegnante, la giornalista o qualsiasi altra cosa. Anche liberare questa visione nelle nostre attività quotidiane significa produrre simbolico; un punto di vista altro che non è previsto, non ha spazio nella visione patriarcale, che si regge proprio sull’aver manipolato e messo a tacere l’altra polarità. La scissione fra corpo, mente e emozioni è uno strumento per l’alienazione dal proprio sé. Noi stiamo imparando a rimetterli insieme, come nell’etica della connessione delle nostre antenate del Paleolitico e del Neolitico.
Tu hai studiato a fondo le antiche società gilaniche (6) europee come anche le odierne culture indigene, che importanza ha in esse la riunione in cerchio delle donne?
I siti archeologici riportano nelle strutture architettoniche la naturalità del cerchio e ci parlano della sua funzione simbolica: non c’è chi comanda sugli altri, ma invece la circolarità della decisione, della riflessione, del prendersi cura. Se guardiamo le società matriarcali contemporanee ci possiamo rendere conto di tutte le riverberazioni pratiche, economiche, sociali e famigliari che ha il cerchio, dove le decisioni sono prese insieme, per consenso. La stessa struttura hanno anche le ruote di medicina dei popoli indigeni, come spiegano alcuni miti molto belli come quello della Donna Ragno. Tessendo la sua tela nelle 4 direzioni la Donna Ragno crea lo spazio, che è la dimensione extra-ordinaria della creazione. Nei miti di creazione femminili, ne parlo in Colei che dà la vita, Colei che dà la forma (7), la “divinità” non crea dal nulla, ma da un contesto già esistente. Questo spazio creativo è quasi sempre circolare, determinato dai punti cardinali associati ai 4 elementi e dal centro, rappresentato dall’etere, l’elemento invisibile, cioè spirituale, quello che tiene insieme e dà un senso al tutto. Applicare alla pratica dei nostri incontri l’essere consapevolmente in cerchio, significa ritagliarsi uno spazio extra-ordinario, lasciare alle proprie spalle tutto quello che ciascuna è nella vita ed essere presenti soltanto con il proprio nome. Si parla una per una, garantendo a tutte uguali possibilità di intervento, o di silenzio. Chi parla sa di doversi contenere, di non divagare, l’ego di una non prende il sopravvento sulle altre. È una comunicazione a un livello distillato, che offre qualcosa di più elaborato rispetto al sapere su di sé. Attraverso l’intenzione e la determinazione di tutte quelle che partecipano al cerchio, prende forma uno spazio di creazione, energetico, che agisce sul piano dell’immaginario. Credo che sia un passo avanti rispetto ai gruppi in cui si creavano dinamiche un po’ selvagge e che i tempi richiedano questo salto. Abbiamo bisogno di un immaginario condiviso, perché ciascuna di noi, da sola, non va lontano. Questo significa riconoscere l’altra donna e l’importanza del sedersi insieme nel Cerchio, in uno spazio protetto ma con l’obiettivo di risvegliare le potenzialità umane disperse da un sistema competitivo e dis-connesso, per riprogettare la realtà comune.
NOTE:
(1) Eva Figes, Patriarcal Attititudes, women in society, Persea Books, New york, 1970; traduzione in italianoIl posto della donna nella società degli uomini, Le radici sessuali economiche religiose psicologiche sociali di una rivolta, Feltrinelli editore, 1970.
(2) Merlin Stone,When God Was a Woman, Harcourt Brace,1976; traduzione italiana Quando Dio era una donna, Venexia-Le Civette Saggi, 2011.
(3) Merlin Stone, Ancient Mirrors of Womanhood: A Treasury of Goddess and Heroine Lore from Around the World, Beacon Press, 1979.
(4) Luciana Percovich,Oscure madri splendenti. Le radici del sacro e delle religioni, Venexia-Le Civette Saggi, Roma 2007.
(5)Marija Gimbutas è l’archeologa lituana che analizzò i reperti della civiltà della Dea in tutta l’area europea, delineando una società evoluta e basata sull’uguaglianza.
(6) Società gilaniche: in cui non c’è predominanza di un sesso sull’altro, come erano quelle dei nostri antenati secondo gli studi di Marija Gimbutas.
(7)Luciana Percovich, Colei che dà la vita, colei che dà la forma, Venexia-Le Civette Saggi,