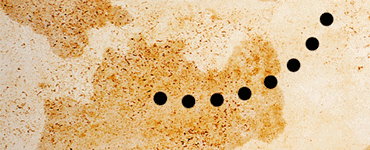La società contemporanea sembra aver cancellato il pensiero e la consapevolezza della morte, ha eliminato ogni senso di finitezza, generando e alimentando l’illusione di “uomo eterno” che può tutto e a nulla e nessuno mai renderà conto.Perchè? E a cosa è funzionale tutto ciò? Ce lo spiega la professoressa Ines Testoni, dirigente del master in Death Studies & The End of Life dell’Università di Padova.
Fin dall’antichità l’uomo si è interrogato sulla morte e su ciò che esisteva dopo di essa. Dalle mummie in Egitto, all’Obolo di Caronte (1) si è vista la morte come un passaggio a una vita futura, e molte religioni tutt’oggi professano una vita ultraterrena.
Se nei secoli passati la morte veniva celebrata sia come rito di passaggio sia perché parte della vita stessa, oggi la sua celebrazione viene delegata alle religioni e allontanata sempre di più dall’aspetto culturale, sociale ed educativo.
A parlare di questo aspetto, è la professoressa Ines Testoni (2), dirigente del master in Death Studies & The End of Life dell’Università di Padova, che spiega come spesso la morte, e tutto il lessico a essa associato, non venga più menzionata nella società di oggi, evidenziando come sia invece urgente riappropriarsi di questa tematica che invece spaventa.
Professoressa Testoni, perché nella società di oggi è avvenuta una censura della morte e di tutto quello a essa associato?
La paura della morte è alla base di tutti i comportamenti umani, sia quelli individuali sia collettivi. Nel campo della psicologia sociale, la Terror Management Theory (TMT) spiega il perché della tendenza a evitare il pensiero della morte, dimostrando con centinaia di evidenze empiriche come essa sia indispensabile per vivere serenamente. Secondo la TMT, l’uomo è l’unico animale cosciente di dover morire e poiché come tutti gli animali ha paura della morte, per poter sopportare tale condizione esistenziale e non essere paralizzato dall’angoscia non può che relegare nell’inconscio la consapevolezza della finitudine. La cultura contemporanea, però, si contraddistingue perché esaspera questa tendenza e si muove addirittura in direzione contraria rispetto all’intera storia dell’umanità. Da sempre, infatti, l’essere umano ha cercato capire il senso della morte fondando tutte le civiltà sulle simboliche dell’esistenza oltre la morte, intorno alle quali le comunità si raccoglievano per celebrare il defunto, manifestando attraverso la ritualità il valore della vicinanza e della coappartenenza. Questo ha caratterizzato anche i comportamenti sociali occidentali fino alla fine del diciannovesimo secolo, grazie alla ritualità religiosa che regolava le relazioni sulla base di valori esistenziali che facevano riferimento alla volontà divina. Siffatta prospettiva permetteva per un verso di lenire il dolore della perdita e per l’altro di concepire le geometrie della trascendenza. Oggi non è più così e qualsiasi ritualità ha perso il proprio potere consolatorio, sostituito da quello del presentismo più assoluto.
Come ha influito in tutto questo la crisi delle religioni?
Quando, in nome di Dio, gli esseri umani sacrificavano la stessa vita, perché erano convinti che così facendo avrebbero guadagnato la salvezza eterna, la morte non era il temibile, lo era invece il peccato, ovvero l’azione non conforme alla volontà divina. Da quando la legge che orienta il comportamento delle persone è diventata positiva, ovvero definita sulla base della volontà umana anziché divina, la vita ha guadagnato un valore supremo e l’uomo è diventato più libero ma ha anche perso i riferimenti di fondo che gli permettevano di pensarsi immortale. Con il pensiero del disincanto, ovvero quello che ha decretato la crisi dei contenuti religiosi, da cui è dipesa la consapevolezza della necessità di ridefinire i costrutti in cui affondano le radici della vita sociale, le persone non sanno più come gestire l’angoscia di morte. Se in passato i discorsi intorno al morire si servivano dunque del linguaggio religioso, oggi essi adoperano un lessico mutuato dall’ambito medico, giuridico e assicurativo. Le stesse religioni, altresì, dinanzi alla morte, sembrano sempre più interessate a questioni terrene piuttosto che a temi che riguardano la salvezza. E questo accade proprio perché sembra che nessuno voglia più scommettere su qualcosa che ci riguardi dopo la vita biologica.
Si è visto che il lessico associato alla morte e al dolore viene evitato. Lei cosa suggerisce di fare per riappropriarsene?
Il linguaggio descrive sempre l’esperienza vissuta e anche il pensiero che dall’osservazione del mondo scaturisce. L’estinzione della capacità di performare collettivamente il cordoglio facendo perno sulle rappresentazioni sacre dell’immortalità ha generato una profonda afasia dinanzi a chi soffre e a chi muore, e innanzitutto dinanzi a noi stessi quando siamo chiamati a fare i conti con i nostri limiti e le nostre perdite. Viviamo immersi in una società che ha interamente esternalizzato dalle relazioni quotidiane l’esperienza della malattia e della fragilità, e da oltre cinque generazioni non si muore più in casa. Tutto ciò che concerne il morire è stato affidato alle pratiche della tecnica medica piuttosto che a quelle degli affetti e della ricerca interiore. La morte è quindi da un lato paradossalmente celata in istituti e ospedali, dall’altro spettacolarizzata dai mass media che contribuiscono a incrementare la percezione che il decesso sia conseguente a eventi eccezionali o violenti. L’assenza di un discorso maturo intorno ai significati del morire deriva dall’assenza di questa esperienza condivisa. Tale carenza ha mutato tanto il rapporto con la morte quanto quello con la vita e con le questioni esistenziali. Per invertire la tendenza sono necessari tre ordini di intervento sociale. Il primo è quello orientato ad accogliere chi soffre per il lutto e permettergli di elaborare nel dialogo con altri questa esperienza. Il secondo è quello che consiste nella predisposizione di percorsi di “death education”, che descrivano e rendano comprensibili le forme con cui l’uomo ha rappresentato il rapporto tra finitudine e trascendenza lungo la storia. Il terzo è quello di recuperare all’interno delle famiglie l’accompagnamento dei propri cari fino alla morte, perché è ciò che gli stessi morenti preferiscono.
Che strumenti e approcci suggerisce per evitare il tabù della morte già dall’infanzia?
Di solito gli adulti non parlano della morte con i bambini, perché temono di causare in loro dei problemi psicologici. Comincia proprio così la censura della morte nella vita dell’uomo occidentale contemporaneo. Genitori e insegnanti cercano infatti di evitare questo argomento e messi di fronte a domande cruciali tacciono o improvvisano narrazioni bizzarre. Queste risposte non fanno altro che incrementare le paure del bambino, provocando fantasie distorte, foriere di incertezza e insicurezze. Poiché però siamo tutti, fin dall’infanzia, paradossalmente esposti a incessanti messaggi mediatici che ci ricordano la nostra caducità è davvero un nonsenso il tentativo di censurare dal dialogo quotidiano su questo tema. È quindi necessario costruire nuovi spazi per una riflessione condivisa che permetta di raggiungere una rappresentazione equilibrata, adulta e matura di che cosa significa finitudine. Dobbiamo poterci rappresentare l’eventualità di ammalarci gravemente e sapere che questo potrebbe interessare prima o poi anche qualcuno che amiamo. La recente legge 219/17 richiede esattamente questa capacità, che ancora non trova alcuno spazio sociale che aiuti gli individui a superare il gap della censura ormai fortemente radicato nella nostra cultura. Una modalità per introdurre un dialogo maturo intorno alla morte e al morire, adeguato per ogni età potrebbe essere, come dicevo, quello offerto da percorsi di “death education”, il cui scopo consiste nell’introdurre un linguaggio competente per parlare della morte, tenendo presente la dimensione trascendentale che il pensiero ha elaborato lungo il corso della storia. Ho realizzato ormai numerosi percorsi di “death education” in tutte le diverse fasi del ciclo di vita delle persone, dall’infanzia all’età adulta, fino alla senilità. Posso dire con certezza che l’argomento sgomenta all’inizio ma poi accende l’interesse e mobilita la riflessione più profonda e significativa. L’ideale sarebbe realizzare questi interventi nei percorsi formativi degli studenti, dalla scuola materna fino alla laurea e come perfezionamento professionale, affidandone l’insegnamento a esperti ben preparati, che devono essere particolarmente abili anche nell’uso di strategie educative appropriate. Siamo molto lontani da questo esito sistematico, ma le esperienze che vanno in questa direzione si stanno moltiplicando dando esiti positivi.
-
La moneta posta nella o sulla bocca di un defunto prima della sepoltura. Le fonti letterarie greche e latine specificano che la moneta si tratti di un obolo e lo motivano come un pagamento o un tributo per Caronte, il traghettatore che trasportava le anime attraverso il fiume Acheronte che divide il mondo dei vivi da quello dei morti.
-
Ines Testoni è docente all’Università di Padova, dove dirige il master in Death Studies & The End of Life. È docente dell’unico corso universitario in Italia di “Psicologia delle relazioni di fine-vita, lutto, perdita e morte”. Ha diretto scientificamente due progetti che hanno coinvolto rispettivamente 5 e 6 Paesi europei, sui temi della violenza e dell’empowering, utilizzando metodi psicodrammatici ed è stata selezionata tra le “100Esperte” a livello nazionale come la studiosa più competente nel campo dei Death studies.ttualmente sta guidando in Italia percorsi di formazione di “death education” per tutti gli ordini di scuola e per i percorsi professionalizzanti nel campo della salute.