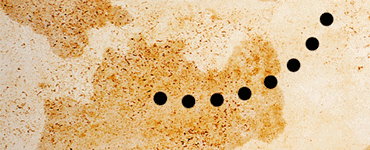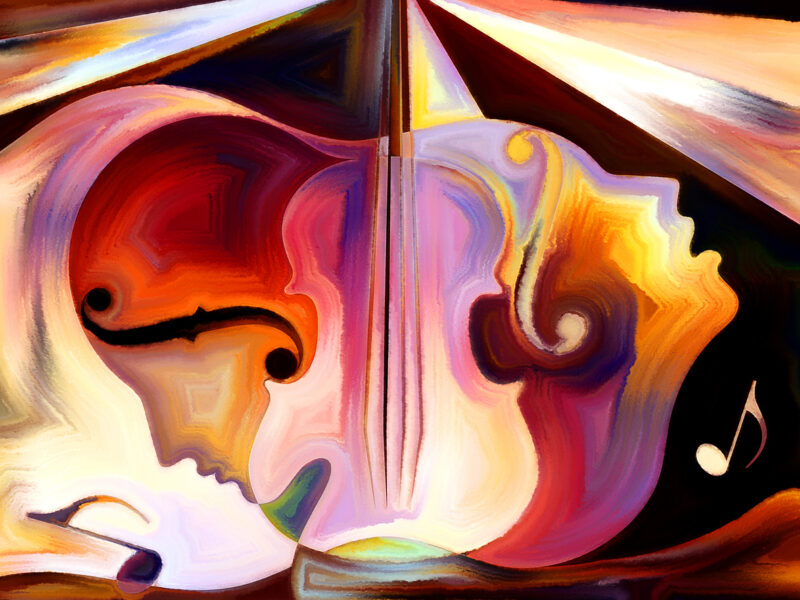Contro il lavoro
homepage h2
Contro il lavoro
Il lavoro in cambio di uno stipendio all’interno di un meccanismo creato per produrre denaro? È alienante. Diventa «il» modo per identificarci, assegna all’individuo un «loculo» nel mondo e lì lo ingabbia, limitandone lo sviluppo delle relazioni e incasellandolo in uno Stato di polizia che impedisce di coltivare la ragione e il desiderio di indipendenza.
Il lavoro impedisce l’invenzione e la sperimentazione di rapporti più ricchi e articolati, ci priva della gioia del saper fare tante attività diverse, e di farle non perché dobbiamo, ma perché ci sembra giusto e necessario per la nostra comunità. La maggior parte degli uomini non si è dedicata spontaneamente al lavoro inteso come produzione di beni destinati a mercati anonimi e sconosciuti, destinati cioè ad alimentare l’economia monetaria. È stato con l’avvento degli Stati moderni e del capitalismo che gli esseri umani sono stati trasformati nella materia prima destinata a una macchina che trasforma il lavoro in denaro.
L’esaltazione del lavoro presenta, per chi detiene il potere, l’enorme vantaggio ideologico di riunire sotto lo stesso vessillo sfruttatori e sfruttati. Si finisce così per considerare il lavoro come un valore; ma se così è, allora significa che questa società considera anche il processo di produzione-consumo un valore fondamentale, prospettiva di per sé agghiacciante. Peraltro è un giochino che permette di schiacciare le libertà, che si riducono solo a quelle necessarie al valore lavoro: poter produrre e consumare liberamente. Il lavoro, dunque, è divenuto un modello di società all’interno della quale non ci resta che il consumo.
Non libera dal lavoro, vuole semplicemente sostituire il lavoro per i padroni con un lavoro collettivo per la comunità in senso astratto. Tutti quanti, nessuno escluso, negano invece la possibilità di una cooperazione spontanea, umana e pacifica; il sistema capitalista si adopera per renderla sempre meno realizzabile, per poter poi arrivare a concludere che è necessaria un’organizzazione coercitiva della produzione per ovviare alla presunta assenza di cooperazione spontanea.
Innanzi tutto quello legato al progresso tecnologico. Capitalisti, comunisti, persino anarchici, ci hanno sempre raccontato che la tecnica, a seconda della direzione che le sarebbe stata data, avrebbe potuto essere messa al servizio dell’emancipazione anziché dell’oppressione. Illusi sono anche i moderni ecologisti soft, che sperano e credono che la tecnologia, sinonimo di miracolosa efficacia, di massima produttività e minimo consumo, possa salvarci dal mondo abbrutito, abbrutente e inquinato. Eppure la storia ci ha insegnato che i balzi tecnologici sono sempre accompagnati da un aumento della pressione sugli esseri umani, una maggiore limitazione delle loro libertà, un’accentuazione del dominio e della repressione contro chiunque contesti questo meccanismo.
Purtroppo la tecnologia, garantendoci nel contempo agi e comodità, ci ha addormentati. Chi, oggi, vuole veramente una reale e completa emancipazione se deve significare la rinuncia al comfort e al consumo? Eppure tecnologia e capitalismo danno molto meno di quanto prendono: lo si vede dalle sterminate masse di poveri nei paesi del Terzo mondo.
Altro mito da sfatare è il concetto di razzismo. Il razzismo non significa volere che ognuno si evolva a modo suo, cercando una propria strada verso l’emancipazione, ma credere che, per emanciparsi, sia necessario svilupparsi esattamente come noi, qui, in Occidente. Ormai bisogna andare oltre anche la decrescita, occorre una critica radicale a tutto ciò che ci rende servi».
Anche questo è un ennesimo mito da sfatare. Quelli che noi consideriamo «selvaggi», dedicano mediamente alla produzione di cibo non più di tre o quattro, massimo cinque ore al giorno; produzione peraltro interrotta da frequenti pause. Il resto è per le relazioni, per se stessi e per la comunità. E non vivono nella miseria, come vorrebbero farci credere, sono invece società dell’abbondanza. È la nostra società contemporanea ad avere creato carestie e povertà su larga scala. Ed è la nostra società ad avere talmente interiorizzato il lavoro da non poterlo più mettere in discussione, se non rimettendo in discussione il senso stesso della vita. Ebbene, è ora di farlo. Pensiamo bene a cosa ci è accaduto. Abbiamo infranto l’equilibrio su cui il tutto si basava. In natura non esiste alcun rapporto di dominio di una specie sull’altra. Le prede non sono «riserve alimentari», sono un elemento del tutto. I predatori non sono dominanti né padroni, ma anch’essi fanno parte del tutto, poiché
in natura le specie sono complementari. L’uomo, nel tempo, si è distaccato da questa visione e, anziché restare un elemento del tutto, si è fatto dominus, trasformando la natura in qualcosa di estraneo a sé, spesso ostile, da piegare e usare come strumento, da sopraffare e asservire. Alienandosi dalla natura, si è alienato da se stesso. La mano di chi cacciava e raccoglieva non è uguale alla mano di chi sfrutta, coltiva intensamente, possiede e accumula. Sono nate così l’economia e la società dei consumi.
Non c’è ideologia che si possa smerciare come ricetta. Anzi, per uscire da questo processo che ci nega come essere umani, occorre demolire tutte le ideologie. Per liberarsi occorre smettere di produrre. La nostra unica scelta è tra il lavoro e la liberazione. Di fronte a un input tanto drastico, molti si spaventano. Invece no, non ci si deve spaventare. La nostra emancipazione passa attraverso la rottamazione di tutto quello che proviene dall’oppressione. Ciò che va ribaltato è l’insieme
del nostro mondo, compresa la sua rappresentazione. Alla caccia-raccolta del paleolitico è seguita l’era della produzione. Tuttavia per superare questa alternativa non si può pensare di tornare all’era pre-agricola, poiché l’ambiente è ormai troppo compromesso. Se consideriamo attentamente gli errori commessi finora, capiremo come la nostra unica speranza sia nella non-azione contro il mondo selvaggio e nella cessazione dell’azione contro la natura. Dobbiamo rifiutare di impegnarci ancora sulla via del progresso. Possiamo inventarci un’esistenza diversa, dalla quale bandire il lavoro. Il non-agire è tutto il contrario del non-intervento. Non è un ritrarsi dal mondo, bensì una critica verso qualsiasi azione contro l’ambiente. Non è un modo di fare la rivoluzione, ma di viverla.