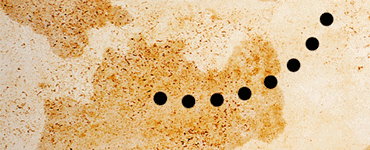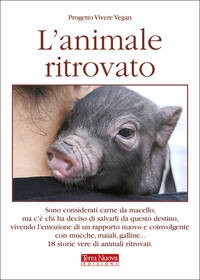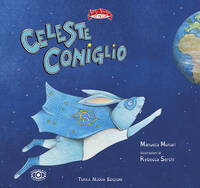Questione animale: che cosa è cambiato?
homepage h2
Anna, intanto grazie per aver accettato questa intervista. Innanzitutto, ci puoi spiegare come si è evoluta la questione animale nel nostro Paese?
Questa legge ha rappresentato un notevole cambiamento culturale, in quanto considera gli animali selvatici come un bene comune piuttosto che come «selvaggina» gestita dai cacciatori. La fauna è diventata «patrimonio indisponibile dello Stato», il quale può autorizzare i cacciatori a effettuarne dei prelievi limitati.
Rivoluzionaria è stata anche la «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (281/91), quasi unica al mondo, che ha riconosciuto il diritto alla vita a cani e gatti che, in precedenza, nei canili pubblici venivano sistematicamente uccisi. Oggi i veterinari possono sopprimere cani e gatti solo per gravi e non curabili motivi di salute.
Il nostro Paese era invece meno avanzato per quanto riguarda la tutela degli animali «da reddito» ma, su questo piano, ha recepito la legislazione europea, introducendo alcune riforme importanti incentrate sul concetto di animal welfare (benessere animale).
Rispetto agli animali «da laboratorio», il Decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014 «Attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» rappresenta sicuramente un passo in avanti. Ci sono state anche leggi di adeguamento a convenzioni internazionali come la «Cites», che si occupa del traffico internazionale di animali e piante in pericolo di estinzione.
E da un punto di vista non legislativo?
Sono nate moltissime associazioni animaliste, come la Lav (Lega antivivisezione), che è forse quella più nota, ma in realtà esistono tante altre organizzazioni, anche locali. Inoltre, il vegetarismo è più diffuso e l’utilizzo di testimonial scelti fra personaggi famosi, come fa per esempio la Lav, ha contribuito a cambiare la percezione pubblica degli animalisti.
Personalmente, credo anche che il crollo del comunismo nel 1989 e il conseguente allentarsi di una logica di contrapposizioni abbia favorito l’animalismo: la protezione degli animali domestici ha smesso di essere considerata come «un’attitudine piccolo borghese», un’etichetta che negli anni ’70 era molto sprezzante.
È interessante notare come, durante il lockdown, sia stata garantita da subito la possibilità di uscire con i propri animali da compagnia, o quella di portarli dal veterinario.
Anche in università, dove il ruolo e il benessere degli animali nella nostra società era un soggetto assai poco considerato, il diritto degli animali è diventato materia di seminari e di corsi post laurea. Purtroppo, secondo me, si fa ancora troppo poca ricerca sul campo.
Esiste un luogo comune, molto persistente, secondo il quale chi ha a cuore la vita o il benessere degli animali si disinteressa degli umani. Che cosa ne pensi?
Che cosa ha significato per te la chiusura dello stabilimento di Green Hill?
Nel tuo libro Il nostro animale quotidiano, metti in guardia contro le forme estremistiche di animalismo. Puo spiegarci meglio?
«Animalista» è colui che si pone il problema morale del trattamento degli animali, di tutti gli animali, non solo dei pet. E tuttavia, dopo aver tolto le barriere fra umani e animali, si apre un vasto campo di rapporti e di contraddizioni per cui non esiste necessariamente una risposta univoca.
Quali sono le principali sfide dell’animalismo oggi?
Nel tuo lavoro, privilegi spesso un approccio etnografico e antropologico. Il tuo articolo sulle gattare è veramente molto interessante. Vuoi accennarci come si è evoluta nel tempo questa figura?
E poi, occuparsi delle colonie di gatti non sembra più essere una prerogativa solo femminile. A Milano, per esempio, pare che circa il 30% dei gattari siano uomini, prevalentemente neo-pensionati, anche se non mancano i giovani.
Nel corso della tua carriera, hai notato un cambiamento nel giornalismo che si occupa di animali?
Glossario
• Animalista. Colui che si oppone, sul piano pratico e filosofico, al trattamento ingiusto degli animali da parte degli esseri umani e ritiene che ogni singolo animale abbia dei diritti, sia un individuo degno della nostra considerazione morale.
• Specista. Termine coniato dallo psicologo inglese Richard Ryder per indicare coloro che discriminano sistematicamente degli animali in funzione delle specie a cui appartengono.
• Antispecista. Persona che, pur non negando le differenze esistenti fra le specie, ritiene che siano tutte ugualmente meritevoli della stessa considerazione morale.
• Zoofilo. Persona che ama, frequenta, cura e protegge alcune specie di animali da compagnia.
• Gattara/gattaro. Persona che nutre e accudisce ogni giorno dei gatti di strada.
• Vegetariani. Coloro che, per ragioni etiche, non si nutrono di alimenti direttamente derivati dall’uccisione di animali.
• Vegani. Coloro che, per ragioni etiche, non si nutrono di qualsiasi alimento di origine animale, compresi latte, latticini, miele e uova, né acquistano prodotti fatti con materiali che implicano lo sfruttamento o la sofferenza degli animali, come cuoio e seta.
Articolo tratto dal mensile Terra Nuova Novembre 2021
POTREBBERO INTERESSARTI
Mucche, maialli, galline… sono tutti esseri senzienti con un’intensa vita emotiva. Ce ne accorgeremmo facilmente se solo cercassimo di avere delle relazioni con loro, invece di trattarli come oggetti e portarli alla fine a cui li condanniamo quotidianamente: una morte violenta per essere “trasformati” in cibo.
Celeste Coniglio è il primo supereroe ecologista e i suoi nemici non sono mostri cattivi o alieni venuti da lontano, ma tutti coloro che maltrattano gli animali.