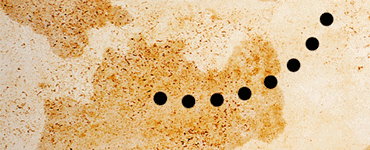Le grandi cifre sono il pane quotidiano dei mezzi di informazione: tra elezioni politiche, manifestazioni, incidenti stradali, guerre, test e borse valori, a volte diventano numeri senza significato. Il rischio più grande è quello di farci l’abitudine e quindi di «esorcizzare», tra i tanti, quei dati che possono avere un peso politico significativo.
Le cifre sono importanti, e proprio per questo sono spesso manipolate: basta un’infarinatura di statistica per rendersi conto di come gli stessi dati possano a volte servire a dimostrare anche due tesi divergenti. Purtroppo, questo capita anche con quei numeri su cui dovremmo riflettere di più: quelli delle vittime di guerra.
Il calcolo delle vite umane sacrificate alla violenza non può assolutamente permettersi dei «giochi» sociologici. Per questo è necessario chiedersi innanzitutto se ha senso parlare del numero di vittime in un territorio di guerra, dove si parte da una difficoltà estrema a reperire dati, per arrivare a tutta una serie di problematiche relative alla loro attendibilità. Normalmente siamo abituati a ricevere solo il risultato finale, che preso da solo ha una maggiore forza mediatica, ma che inevitabilmente finisce per essere poco consistente, in quanto privo di un contesto.
Lo studio pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista inglese Lancet, condotta sulle vittime civili della guerra in Iraq, riporta per filo e per segno tutte le problematiche intrinseche ad un’indagine del genere. Questo tipo di approccio, invece di cadere in un relativismo, acquista una grande forza: il dato conclusivo, infatti, ha un senso solo in relazione alla volontà di un’indagine diretta, che tenga conto dell’attendibilità sia prima che durante e dopo la raccolta dei dati.
Lo studio è stato condotto da un gruppo di scienziati americani ed iracheni del Bloomberg School of Public Health (MD, Usa), della Columbia University (NY, Usa) e dell’Università di Al-Mustansiriya (Bagdad, Iraq). «I nostri risultati hanno bisogno di un’ulteriore verifica e saranno sicuramente soggetti a correzioni» afferma Les Roberts, direttore della ricerca. «Tuttavia, abbiamo dimostrato che la raccolta di dati sulla salute pubblica è possibile anche in periodi di estrema violenza».
Dalla guerra del Golfo del 1991, il numero di iracheni vittima di conflitti o sanzioni punitive non è rintracciabile: si va dalla negazione di un aumento della mortalità alla segnalazione di milioni di morti. Si è dovuto quindi ricorrere ai dati del Ministero della Salute.
Il conto degli iracheni uccisi dalle forze di coalizione attualmente è tenuto dal progetto Iraq Body Count (www.iraqbodycount.net), un monitoraggio «passivo» basato sulle segnalazioni dei media e che non tiene conto delle vittime indirette del conflitto armato.
Nell’attuale clima di incertezza e nell’impossibilità di reperire dati sulla salute pubblica del paese, un gruppo di scienziati statunitensi e iracheni ha affrontato i pericoli inevitabili di un rilevamento diretto, registrando i livelli di mortalità 15 mesi prima e 18 mesi dopo l’invasione. Ogni gruppo di lavoro era composto da un intervistatore maschile e uno femminile; cinque dei sei intervistatori iracheni era no medici e tutti e sei sapevano bene l’inglese e l’arabo.
La coraggiosa troupe investigativa ha intervistato 988 famiglie in 33 aree diverse dell’Iraq durante il mese di settembre 2004.
Con l’aiuto di un Gps, gli intervistatori hanno selezionato, a campioni randomizzati, le città con un governorato, per poi visitare 30 delle abitazioni più vicine al punto selezionato. Alle famiglie è stato chiesto il numero e la natura dei morti prima e dopo la guerra, arrivando a coprire un numero di 4300 persone.
A tutti gli intervistati veniva assicurato l’anonimato e la libertà di non partecipare all’indagine. Alla fine dell’intervista, veniva chiesto se si sapeva di famiglie intere che erano scomparse o i cui pochi superstiti erano fuggiti altrove: questo diminuiva il margine di errore dato dalle famiglie che non potevano rispondere all’intervista perché non più sul posto.
Per limitare i rischi ai ricercatori, i governatorati sono stati presi a coppie vicine: questo ha ridotto di un terzo gli spostamenti complessivi, ma allo stesso tempo ha inevitabilmente aumentato le variazioni tra i tassi di mortalità nei punti scelti, riducendo quindi la precisione del tasso nazionale.
È stato fatto anche un tentativo di confermare le morti registrate, chiedendo un certificato di morte in almeno due famiglie per ogni punto scelto; non di più perché gli intervistatori hanno affermato che nella cultura irachena è poco probabile che ci si inventino i morti: supporre questo avrebbero potuto provocare anche delle reazioni violente. Tuttavia, il numero dei componenti familiari potrebbe essere stato comunque falsato da una volontà di giustificare una maggiore distribuzione di razioni alimentari, nonché dalla volontà di nascondere la morte di combattenti, abbassando in questo modo la stima finale.
Alla fine, il numero di vittime del conflitto è stato calcolato sottraendo il tasso di mortalità prima dell’invasione da quello successivo al 18 marzo 2003 e moltiplicando quel dato per la supposta popolazione dell’Iraq – 24,4 milioni all’inizio del conflitto – e il periodo di tempo intercorso dal 19 marzo ai giorni della raccolta dei dati. Anche qui, l’uso di stime governative di popolazione potrebbe aver escluso le fasce non rappresentate, come i senza tetto, i non residenti e il personale militare.
Il punto scelto di Falluja è stato quello più problematico, prima di tutto perché è stata la città più violenta in Iraq durante i giorni del rilevamento. Inoltre, era l’unico luogo dove era compromesso l’utilizzo del Gps, a causa dell’alto rischio di essere vittime di strategie militari con apparecchi satellitari.
A Falluja, il 44% delle case visitate era temporaneamente o permanentemente abbandonato. Questo presenta la possibilità che le persone rimaste siano state le più fortunate – sottovalutazione – oppure che siano fuggite e ancora vive – sopravvalutazione.
Infine, gli intervistatori potevano essere capitati in un’area atipica del punto scelto di Falluja. Tuttavia, siccome il 71% delle morti violente e il 37% dei morti durante il conflitto sono avvenuti in uno solo dei punti scelti, è possibile che per una straordinaria coincidenza la stima di mortalità sia stata deviata verso l’alto.
Comunque sia, c’è da dire anche che nella ricerca casuale dei punti da analizzare, altre città altamente danneggiate come Ramadi, Najaf e Tallafar non sono state prese in considerazione. In più, il punto scelto a Thaura (Sadr City), teatro dei più intensi combattimenti di Bagdad, è risultato un quartiere illeso, con nessun morto nei mesi di conflitto.
Il tasso di mortalità calcolato durante il periodo di guerra è stato di 12,3 per 1000 persone all’anno. Più di 1/3 degli intervistati ha riportato decessi avvenuti dopo l’invasione e 2/3 delle morti violente è avvenuta nel territorio di Falluja.
Le principali cause di morte prima della guerra erano infarto del miocardio, incidenti cerebrovascolari e le conseguenze di altri disturbi cronici, per un totale del 48% delle morti riportate.
Dopo l’invasione, la causa di morte più comune è diventata la violenza, sia includendo (51%) che escludendo (24%) il caso Falluja. La mortalità legata alla violenza è aumentata di 58 volte ed è risultata geograficamente diffusa, poiché riportata nel 45% dei punti scelti.
Le interviste non attribuiscono la maggiore responsabilità ai soldati da terra: infatti, solo il 5% delle morti violente riportate hanno avuto a che fare con uccisioni dirette con armi leggere da parte di soldati della coalizione. Il restante 95% è stato causato da vari tipi di armi aeree.
Forse il dato più preoccupante è che la metà delle uccisioni causate dalle forze occupanti ha colpito donne e bambini.
Escludendo l’anomalia di Falluja, lo studio riporta una stima di 98.000 morti in più dall’inizio della
guerra. Si è arrivati quindi ad una stima complessiva di 100.000 morti, un dato che potrebbe essere molto più alto. Nonostante le circostanze estreme, la raccolta di dati è stata comunque possibile e la precisione limitata non impedisce di identificare con chiarezza quale sia attualmente il maggiore problema di salute pubblica in Iraq: la violenza.
Il generale americano Tommy Franks ha detto più volte: «Noi non contiamo i morti». Tuttavia, visto che l’articolo 27 della Quarta Convenzione di Ginevra stipula che le persone protette debbano essere in ogni momento trattate umanamente e difese specialmente da atti di violenza, gli scienziati di questo rilevamento si chiedono come si possa verificare il rispetto di questo articolo senza un impegno costante ad attuare dei conteggi sistematici.
La presente ricerca acquista quindi un’importanza politica e non solo mediatica, in quanto ha dimostrato che è possibile, «con fondi modesti, quattro settimane e sette iracheni disposti a rischiare la vita», ottenere una misura utile delle vittime civili in un territorio di guerra. Di conseguenza, non sembrano esserci delle scuse sufficienti per non fornire dei dati più precisi da parte dei paesi occupanti.
«Questi risultati dovrebbero essere confermati da un corpo indipendente come l’Icrc, l’Epicentre, o l’Organizzazione Mondiale della Sanità» concludono i ricercatori. Nel frattempo, si tratta di rivalutare le conseguenze dell’uso delle armi da parte dalle forze della coalizione nelle aree popolate, sia per una questione di interesse comune che come puro e semplice atto di civiltà.