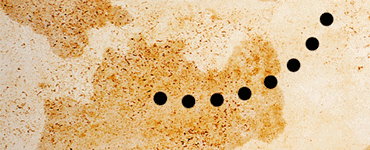Nel 1965, Lisa Berkman e Leonard Syme, due epidemiologi sociali, decisero di mettersi ad osservare gli abitanti della Contea di Alameda, in California. Ci tornarono per altre due volte ad osservarli, nel 1974 e nel 1983, per vedere se qualcosa era cambiato. Quello che scoprirono, fu che chi stringeva più relazioni, o faceva parte di associazioni, o si rendeva utile per la comunità, aveva livelli di salute più alti e viveva di più. Questo studio è conosciuto come Alameda Study e introduce un nuovo concetto di salute, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. Per la prima volta, dunque, la salute è un benessere poliedrico, che mette in comunicazione mente, corpo, relazioni e socialità.
Il luogo in cui questo tipo di benessere si può esprimere nella sua forma più genuina e profonda è la casa.
Il cohousing è una forma un po’ strana di casa. Spesso è una casa molto grande, con tante altre piccole case dentro, ci si vive tutti insieme, ma ognuno ha il suo spazio. Si condividono spazi, valori, compiti, ideali, ed è una scelta di vita consapevole di chi di quella salute sta piuttosto bene.
C’è però chi di quella salute non sta così bene e si ritrova a doverne far fronte in zone di assistenza, residenze terapeutiche, in sistemi istituzionalizzati chiusi che non dialogano con l’esterno.
Numerose ricerche, invece, hanno dimostrato che le comunità intenzionali possono funzionare meglio di quelle terapeutiche in quanto si fanno luogo di sicurezza e socializzazione, e surrogato della famiglia istituzionale (Whitley et al., 2008).
Non si vuole proporre una sostituzione della coabitazione alle soluzioni cliniche terapeutiche, che rimangono fondamentali per una gestione completa delle difficoltà dell’individuo, ma si vuole suggerire una soluzione da valutare e da considerare nella strada verso il benessere dell’individuo.
Inserire qualcuno che vive una situazione di disagio, in un contesto di vita quotidiano, può essere un punto di partenza per mettere nelle mani della persona stessa la propria cura, lavorando sul ruolo salvifico della relazione e del vicinato, attivandosi nello scambio e nella presa in cura del proprio ambiente di vita, rendendosi in grado di comprenderlo e sentirsene parte.
La convivenza, infatti, permette la nascita di relazioni. Le relazioni facilitano il rendersi partecipi della propria realtà, attivandosi per questa e aumentando il proprio livello di empowerment, ossia il grado di controllo di una persona nelle vicende della propria vita. Questo, influenza il capitale sociale, che è l’insieme delle relazioni necessarie al funzionamento di una società. Tutti questi elementi, hanno un effetto così sul benessere e sulla salute dell’individuo.
Randell e Cumella, nel 2009, hanno fatto uno studio etnografico sulla comunità di Botton Village, in Inghilterra, una comunità che garantisce un’abitazione permanente a più di mille persone di cui circa la metà con ritardo mentale.
Dal loro studio, gli autori, trovano che i fattori positivi della comunità intenzionale, sulla salute dei residenti con disabilità, siano rintracciabili in fattori quali: l’assenza di una subordinazione fra residenti e staff, la facilità di stringere amicizia con altre persone con ritardo mentale, alti livelli di occupazione e impegno significativo e un generale senso di comunità.
Botton Village riprende gli ideali di Karl König, un pediatra austriaco che fondò il
Camphill Movement, un movimento di comunità terapeutiche intenzionali per persone con bisogni speciali o disabilità. König (1956) sosteneva che tutte le persone avessero pari valore, in quanto ogni essere umano è portatore di una personalità interiore sana, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche o dalle disabilità. Di conseguenza, ognuno ha diritto alla stessa considerazione e alle stesse opportunità di tutti gli altri, ed ognuno è valutato per il suo contributo alla vita della comunità. La comunità intenzionale, secondo König, crea una vita per coloro che sono incapaci di trovare un posto nella competitività del mondo esterno, evitando però di farsi manicomio.
In Italia, di queste realtà ce ne sono alcune. Alcune sono in piena città, altre un po’ fuori, alcune si chiamano “solidali”, altre hanno il prefisso “eco-”. Non sanno tutte di essere cohousing, alcune si dicono “villaggi”, altre “coabitazioni”, d’altronde, il manifesto della rete del cohousing, non prevede un’integrazione intenzionale fra persone che stanno piuttosto bene e persone che non stanno così bene. Il cohousing fa riferimento ad altri principi, come la relazione, il vicinato, la partecipazione, la mancanza di gerarchie, la socialità, l’appartenenza ad un luogo, tutti principi che vanno a creare una nuova forma di cura che parte da un quotidiano nel quale sono possibili le condizioni perché l’individuo possa far fronte alle sue difficoltà in un modo altro. In questo modo si creano delle realtà di vita dove non si cura l’altro, ma ci si prende cura dell’altro, chiunque sia e da dovunque venga, in modo tale che, come dice Weihs (1988), la diversità diventi una varietà invece di un’anomalia e che proprio la diversità, piuttosto che l’uniformità, diventi fondamento della vita sociale sana.
Articolo scritto da:
Elena Giulia Massaggia, laureata in Psicologia Scolastica e di Comunità. L’articolo è un estratto della tesi di laurea sulla coabitazione come alternativa abitativa per persone in situazione di svantaggio psicosociale, con un’analisi di caso sul campo della realtà “Villaggio Solidale” di Mirano (VE).
Contatti: elena.massaggia@gmail.com
Note:
König K. (1956) A chapter in community living. In: Farrants, W. (ed.) (1988). Camphill Villages. The Camphill Press, Danby.
Randell, M., & Cumella, S. (2009). People with an intellectual disability living in an intentional community. Journal of Intellectual Disability Research, 58, 716-726
Weihs T. (1988) An appreciation of the village community. In: Farrants, W. (ed.) (1988). Camphill Villages. The Camphill Press, Danby., pp 17-19
Whitley, R., Harris, M., Fallot, R., & Wolfson Berley, R. (2008). The active ingredients of intentional recovery communities: Focus group evaluation. Journal of Mental Health, 17(2), 173-182